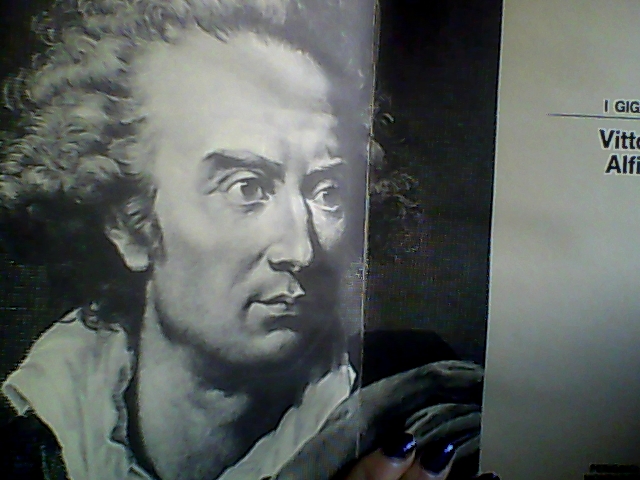Tratto da
Odore di violette. Questo dovrebbe mettere in allarme i vostri sensi e spingervi a fuggire a perdifiato fuori dal parco, il più lontano possibile da quella donna. Ebbene sì, chi decide di attraversare il Parco Sempione d'inverno non pensi di essere al sicuro. Magari è anche una di quelle notti in cui improvvisamente cala una nebbia da non vedere dove mettere i piedi. Proprio in queste condizioni si racconta che compaia ai più incauti la dama del parco.
è una donna interamente vestita di nero. Il volto coperto da un velo di organza scura. I suoi passi non fanno rumore sul brecciolino dei vialetti del parco, quasi, anzichè camminare, volasse sfiorando il terreno. Odore di violette e un freddo più intenso di quello che già l'inverno porta con sé. Questi i sintomi che annunciano qualcosa di strano. Anche se non potete vederla in viso, la donna emana bellezza e fascino. Dal suo corpo si sprigiona qualcosa di infinitamente attrattivo e allo stesso tempo immensamente triste. Dovreste allontanarvi, ma ormai lei è troppo vicina. Fissate i contorni del volto, che appena si intravedono da dietro il velo, e il vostro cuore è già suo. Come lo fu il cuore di decine, se non centinaia, di passanti prima di voi.
La dama allunga una mano, gelida come la morte, afferra la vostra e vi conduce lungo i viali del parco. Provate a guardare la strada e a ricordarla. Sarà impossibile. Chi prima di voi è caduto vittima di questo sortilegio non è più riuscito a ritrovare la strada fatta con la donna. La strada che conduce alla sua villa.
Al suo interno, tra candele e pareti listate a lutto, vi lancerete con lei in un vortice di danze, senza mai guardarla in volto. Anche quando vi condurrà in camera e vi spoglierà, il suo volto continuerà a restare coperto. Solo quando sarà nuda vi permetterà di vedere che cosa c'è sotto l'organza del velo.
Chi ha vissuto questa esperienza, difficilmente è rimasto sano. Alcuni, visto il teschio morto che sostituisce il volto della donna, si sono dati alla fuga e non hanno più ritrovato la serenità. Ma peggio è andata a coloro i quali, nonostante il teschio, sono rimasti innamorati e affascinati dalla donna, tanto che hanno trascorso il resto della loro esistenza vagando per il parco alla ricerca della villa della loro amata.
I primi racconti relativi alla dama del parco risalgono alla fine dell'Ottocento. I milanesi presero molto sul serio la leggenda e soprattutto la pazzia di chi veniva irretito nel parco di notte, e organizzarono decine di spedizioni per trovare la misteriosa villa della donna. Ovviamente mai nessuna ebbe successo.
Ma Milano è una città traboccante di fantasmi.
Come ogni città ricca di storia, la maggior parte dei suoi fantasmi riguarda fatti di sangue accaduti in passato.
Al Castello Sforzesco, per esempio, di notte è possibile incrociare lo spettro di Ludovico il Moro che, con ancora nelle mani i gioielli del suo tesoro, cerca di sfuggire alla congiura che porterà alla sua caduta.
Bona di Savoia la potreste invece vedere a una finestra, che piange per la perdita dei suoi congiunti. Le sue urla si mescolano a quelle di Beatrice d'Este che sta morendo dissanguata dopo aver dato alla luce suo figlio. Sotto il portico dell'Elefante a molti è capitato di vedere invece Isabella d'Aragona che corre a prendere il veleno con cui cercherà di uccidere gli Sforza. Sempre al castello alcuni raccontano dello spettro di Isabella di Lampugnano che, divertita, fa scherzi ai turisti. Si tratta del fantasma di una strega torturata e uccisa con l'accusa di aver mangiato dei bambini.
Altri ancora sono i luoghi in cui nere figure si aggirano per la città: in corso Monforte le ombre a volte si piegano e si contorcono fino ad assumere sembianze femminili. Decine, centinaia di donne. è la processione delle mogli e delle figlie dei catari fatti sterminare da Ariberto di Intimiano, vescovo di Milano, che fece bruciare i loro corpi proprio in corso Monforte.
Nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana, davanti alla teca che contiene la ciocca di capelli che Lucrezia Borgia aveva donato a Pietro Bembo, come pegno d'amore, lo spirito della donna armeggia per tirare fuori i capelli. Ogni notte Lucrezia li pettina e poi li rimette al loro posto. Questo è il motivo, inspiegabile per molti ricercatori, per cui a distanza di secoli quei capelli sono ancora morbidi e belli, come se fossero stati tagliati solo ieri.
A Brera le telecamere hanno invece ripreso una figura circonfusa di luce che ha fatto scattare tutti gli allarmi.
Riguardando il filmato una figura femminile emerge dal quadro "Ninfa dei boschi" di Bernardino Luini. La figura si volta, indica il quadro e poi scompare lungo i corridoi. Quando l'opera di Luini fu esaminata ai raggi X ci si accorse che era stato dipinto sopra un quadro più antico del XII secolo. La cosa assurda è il soggetto di questo quadro, un oggetto discoidale adagiato in un campo con intorno figure umanoidi con quattro braccia. La rappresentazione di un atterraggio alieno di quasi mille anni fa? Non lo sapremo mai visto che oggi il quadro è scomparso e gli stessi responsabili di Brera non sanno che fine abbia fatto.
Ma gli spettri di Milano non appartengono solo a personaggi famosi e noti.
Decine di fantasmi di poveri disperati camminano per le vie della città addormentata. In piazza Maggi si aggira lo spirito di un anziano morto pazzo al manicomio della Senavra (che si trova poco distante, in corso XXII Marzo). Il fantasma segue i passanti. L'unico modo per liberarvi di lui è gettarvi qualche moneta dietro alle spalle. Inspiegabilmente, compiuto questo gesto, lo scalpicciare dei passi dietro di voi cessa improvvisamente.
In via Aldini parecchi testimoni hanno raccontato un episodio molto inquietante. Un uomo anziano, descritto come un pazzo, si getta all'improvviso in mezzo alla strada per farsi investire. Dopo la frenata e la comprensibile paura, di lui non resta nessuna traccia. A volte lo si vede ricomparire alcuni metri più in là, raccolto in preghiera, davanti a un'udicola dedicata alla madonna immacolata. Sembra si tratti dello spettro di un anziano morto al Palazzolo, l'ospizio per barboni, costruito lì vicino da Luigi Palazzolo all'inizio del Novecento. In via Macenate non è raro imbattersi invece nello spettro di un uomo in giubbotto di pelle, sciarpa bianca e occhialoni. è un aviatore che sta cercando gli stabilimenti della Caproni (storica ditta costruttrice di aerei) che sorgevano proprio in questa via.
E ancora, davanti alla chiesa di Santa Maria del Suffragio si vedrebbero oscure figure camminare in cerchio. Le urla di un uomo murato vivo proverebbero ogni notte dal campanile della chiesa di Santo Stefano. Un monaco comparirebbe dalle parti del Cimitero Monumentale, continuando ad inveire e urlare contro l'immoralità dei costumi odierni. Una donna nuda si mostrerebbe ai passanti in Porta Vittoria.
Non solo di uomini sono gli spettri di Milano. In via Cadore molte testimonianze parlano dello spirito di un grosso cane nero che avrebbe la malaugurata abitudine di alitare acetilene sui passanti.
Vedi anche: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/08/il-fantasma-di-bianca.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/08/i-fantasmi-del-castello-di-trezzo.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2016/11/la-chiesa-dei-morti.html
http://deisepolcriecimiteri.blogspot.com/2018/07/fantasmi-in-italia.html
https://deisepolcriecimiteri.blogspot.com/2018/07/fantasmi-elenco-di-celebri-apparizioni.html
Invito alla lettura di Alfonso Varano
Tratto da
Il poeta delle "Visioni" prende, se non vita, rilievo stereoscopico al limite delle classi contigue del passato e del futuro letterario: il suo passato si chiama maniera grande delle province pontificie, tradizione dantesca e cultura delle Legazioni: il suo futuro, richiamando ad uno ad uno gli stessi termini storico-geografici, si chiama Monti, il suo corregionale più illustre, dai tempi della devoluzione estense e della guardia assunta dai Cardinali Legati alla linea del Po. Quando poi si prescinda dal capitolo illustre della fortuna di Dante oltreappennino, la cronologia (nato nel 1705, morto nel 1788) ed il gusto poetico richiamano al Barocco, che è pure una costante sottointesa all'Arcadia Neoclassica ad unire o almeno a gettare un ponte fra Secentismo e Romanticismo. Per questa via i preliminari alla sua lettura si imbattono nel Frugoni più enfatico e descrittivo e lì si concludono.
VISIONI
IL PRECIPIZIO
Trattandosi di "Visione", è di prammatica la terzina dantesca; ma è evidente che lo scrittore lavora nell'esterno a ricostruire gli effetti di quella poetica del forte immaginare che in Dante era psicologicamente ed esteticamente una situazione originaria, un dato primordiale ed elementare del suo rivivere; e che il sussidio più valido gli viene dato dalla cultura e dalla maniera grande che persegue volenteroso. Ha il suo valore che fra Dante e Petrarca scelga, stimolato dall'ambiente, Dante; ed è singolare che l'osservazione assidua dei particolari naturalistici, proprio della prosa scientifica, sia irrobustita e proclamata da contrasti scenografici di luci e ombre.
Era tranquillamente azzurro il mare,
ma sotto a quella balza un sordo e fisso
muggito fean le spumanti acque amare;
ché un fiume, cui fu dal pendío prefisso
cieco sotterra il corso, ivi formava
co’ moti opposti, un vorticoso abisso.
Desío di rimirar qual s’aggirava
a spire il flutto, e tratto poi dal peso
perdeasi assorto nell’orribil cava,
me mal saggio avviò fin allo steso
dentro i profondi golfi orlo del masso,
e da incauto affrettar
così fui preso,
che sul confin io sdrucciolai col passo.
Dall’erta caddi, e un caprifico verde
afferrai sporto fuor del curvo sasso.
Gli spirti, che il terror fuga e diperde,
corsermi al cor lasciando in sé smarrita
l’alma, che il ragionar stupida perde.
In cotal guisa l’infelice vita
sospesa al troppo docil tronco stette
fra certa morte e vacillante aita.
Su l’onde in rotator circoli strette
fissai, ritorsi, chiusi le pupille
da un improvviso orror vinte e ristrette;
e tal ribrezzo misto a fredde stille
d’atro sudor m’irrigidì le avvinte
mani al sostegno mio, che quasi aprille
fra cento vane al mio pensier dipinte
idee, che furo in un momento accolte,
e cangiate, e riprese, e insiem rispinte.
Sconsigliato tentai colle rivolte
piante, e al dirupo fitte, arcando il dorso,
arrampicarmi alle pietrose volte;
ma il piè a toccar la roccia appena scorso
era, che il ritirai, dubbio qual fosse
peggior o il mio reo stato, o il mio soccorso;
perché all’arbor, che al grande urto si scosse,
temei col raddoppiar l’infausta leva
sveller affatto le radici smosse.
Grida tronche da fremiti io metteva,
che dai concavi tufi e dalle grotte
un eco spaventevol ripeteva.
Già dal forzato ceppo aspre e dirotte
sul corpo mi piovean ghiaie ed arene,
e l’ime barbe già scoppiavan rotte;
già l’alma ingombra avean larve sì piene
di morte, che pareami, anzi io sentia
le inghiottite acque entrar fin nelle vene;
perché il vortice infranto, che salía
in larghi spruzzi dai spumanti seni,
col ribalzato mar mi ricopria.
[...]
DELLA VANITà DELLA BELLEZZA TERRENA PER LA MORTE D'AMENNIRA
Tomba feral, ma nel coverchio aperta,
che parea da tremoto, o turbin fiero
pel diroccato suo colmo scoperta.
Vergate d’oro in un macigno nero
Tai brevi rilucean lugubri note:
sacro all’ottimo Dio massimo e vero.
Quella, che fia specchio all’età rimote
del vedovile onor, che afflitto or tace,
nota in pietade anche alle genti ignote,
Amennira (ahi che lessi!) oimè! qui giace.
Chiunque l’orme in queste sabbie imprime,
riposo preghi alla sciolt’Alma e pace.
Ristetti, inorridii, sdegnai le prime
incaute brame, che me spinser lasso
quelle a calcar piagge deserte ed ime;
poi vergogna ed amor al dubbio passo
diér moto sì, che lentamente salse
pe’ gradi, che cignean il tetro sasso:
ma ribrezzo in toccar l’urna m’assalse,
e la mia lena interna al terror mista
il gel nascente a superar non valse.
Tremando alfin afferrai l’orlo.
Ahi vista squallida,
lagrimevole, dogliosa,
Ahi d’umana beltade immagin trista!
Su letto di putredine schifosa
Giacca dal tempo nel suo morder forte
l’estinta spoglia avidamente rósa:
fitti i rai spenti entro l’occhiaje smorte,
guaste le labbra, aperto il petto, e Fanclie
gonfiate, e tinte di livida morte:
rigide e impallidite le man bianche,
dilacerato il grembo, e combattuto
dalle serpi non mai nell’ira stanche:
lezzo, noja ed orror quel, che rifiuto
fu degl’ingordi vermi, ed era in lei
la più vezzosa parte il cener muto.
Abborrii sì que’ lordi avanzi e rei,
che colla fronte addietro volta io mossi
giù dagl’infausti gradi i passi miei;
e colmo di stupor, quasi un Uom fossi
che sogna, e a sè chiede se vegli, o dorma
fra i dubbj dal sognar stesso in lui mossi,
a me chiedea: vera, o ingannevol forma
gli affascinati miei sensi delude?
Travidi? o pur del piè la stabil orma
lasciai su queste solitudin crude?
Chi ad Amennira alzò tomba sì grande
in terre d’ogni ancor vil pianta ignude?
O forse il nome addita altra, che spande
pari onor, Donna estinta, ed a me sembra,
che sue sieno le offerte altrui ghirlande?
Ma qual altra in virtude egual rassembra
a lei, che amore e morte in cor mi pose?
E di chi son quelle infelici membra?
Quelle son, che tu amasti, ella ripose.
[...]
Né mesto, ma tranquillo il viso grave,
e maggior dell’antica era l’immago.
La mente, che le larve oscure pave,
dal leggiadro sentì Spettro diffusa
maravigliosa in sé luce soave;
e dalla piena calma al core infusa
argomentò, che quella fosse un’Alma
O dal Ciel scesa, o in pace a viver usa.
Fiso io guardava l’impalpabil salma,
ch’ove avvien, che il vel doppio in sen trabocchi,
stretta avea l’una insieme all’altra palma,
e all’alto i lumi da pietà sì tocchi
volgea, che mai lassù non fùro affissi
nè più amorosi, né più amabil’occhi.
Tacendo essa, io pur tacqui, o non ardissi,
O me rendesse muto il mio stupore.
Confuso alfin ruppi il silenzio, e dissi:
O mia misera speme, e mio dolore,
fra le spolpate nel funereo seggio
Ossa tue carche di cotanto orrore, Amennira,
ed è ver ch’io ti riveggio?
O pur fra i sogni e i simulacri vani
del mio turbato immaginar ondeggio?
Da quali ignoti spazj, e alberghi arcani
degli astri, o degli abissi a me tu vieni
tratta di Morte dalle ferree mani?
Ma da qualunque a me sede ti meni
sì amico volo, ah! tu soave spiri
grazia, e fra il lutto ancor mi rassereni.
[...]
LE SORGENTI DELL'ARNO
L'autore, fra barocchismo e Preromanticismo, rende "orrendo" quel paese di Falterona, così prossimo alla mite estasi della Verna. "Crudo sasso" per altro, nella scenografia dantesca delle Stimmate. Stilemi naturalistici e lucreaziani a stento trovano un varco fra le reminiscenze arcadiche.
Vago di penetrar perchè Natura
non mai d’Arno gli umori appien consumi,
e incerto ancor, se del mar l’onda impura
per sotterranee ghiaje e schiusi dumi
feltrata salga alle montagne, e scenda
partita in rivi, ed in perpetui fiumi,
io l’erta ascesi d’una roccia orrenda,
che in mezzo all’Appennine Alpi nevose
le vie Tosche e l’Emilie avvien che fenda;
Ch’ivi scontrando ognor le rigogliose
acque scorrenti dall’origin prima
disvelarne credei le fonti ascose.
Stendeasi larga quell’alpestre cima
in scabri sì, ma rinverditi prati,
benché ad aspro soggetti indocil clima:
Questi d’argin informi, e di solcati
dorsi, e di gore, e d’ineguali fosse
in varie strane fogge eran vergati.
Cento scorgeansi in essi, ove serbosse
la pioggia, late vasche, altre già vote
d’acqua, altre sceme, altre ricolme e grosse.
Di là salii balze più eccelse, e note
solo ai rapaci augelli, e trovai boschi,
spelonche e abissi, in cui giaceano immote
le nevi e ghiacci, o splenda il giorno o infoschi,
non mai squagliati, perchè troppo inerte
È il sole a riscaldar quegli antri foschi.
Vidi in altre caverne al ciel scoperte
grondar le linfe dal pendio condotte
delle inzuppate, e ai raggi terre aperte;
e da più alte selve altre dirotte
fonti precipitando in tufi e in greppi
perdersi dentro a fesse rupi e a grotte.
Lassù pur il camrain fra schegge e ceppi
rósi, e pomici mai non viste altrove
tentai, né come il superassi io seppi;
e colà rimirai voragin nove,
e rappresi entro a quelle, e sciolti umori
del Libic’austro per l’estreme prove,
e campi squallidissimi peggiori
di quel ch’Uom finger possa, alberghi solo
di nevi e di gelate acque e d’orrori.
Da tai di tante piogge in erto suolo
serbatoi vasti un sovra l’altro stanti,
e dal vario del sol girar dal polo,
e dai venti fra lor vario-spiranti,
e dai vapor, che il sotterraneo foco
alza entro al monte, e striscian fuor grondanti,
argomentai, che il misto ordin del loco
a prestar atto sia continue l’onde
spinte in giù dalla scesa a poco a poco
O fra sterili sassi, o erbose sponde;
E il fiume tragga sol perenni l’acque
Dai montani antri e vasche, e non d’altronde.
[...]
Vedi anche: https://deisepolcriecimiteri.blogspot.com/2020/10/dallilluminismo-al-preromanticismo.html
Il poeta delle "Visioni" prende, se non vita, rilievo stereoscopico al limite delle classi contigue del passato e del futuro letterario: il suo passato si chiama maniera grande delle province pontificie, tradizione dantesca e cultura delle Legazioni: il suo futuro, richiamando ad uno ad uno gli stessi termini storico-geografici, si chiama Monti, il suo corregionale più illustre, dai tempi della devoluzione estense e della guardia assunta dai Cardinali Legati alla linea del Po. Quando poi si prescinda dal capitolo illustre della fortuna di Dante oltreappennino, la cronologia (nato nel 1705, morto nel 1788) ed il gusto poetico richiamano al Barocco, che è pure una costante sottointesa all'Arcadia Neoclassica ad unire o almeno a gettare un ponte fra Secentismo e Romanticismo. Per questa via i preliminari alla sua lettura si imbattono nel Frugoni più enfatico e descrittivo e lì si concludono.
VISIONI
IL PRECIPIZIO
Trattandosi di "Visione", è di prammatica la terzina dantesca; ma è evidente che lo scrittore lavora nell'esterno a ricostruire gli effetti di quella poetica del forte immaginare che in Dante era psicologicamente ed esteticamente una situazione originaria, un dato primordiale ed elementare del suo rivivere; e che il sussidio più valido gli viene dato dalla cultura e dalla maniera grande che persegue volenteroso. Ha il suo valore che fra Dante e Petrarca scelga, stimolato dall'ambiente, Dante; ed è singolare che l'osservazione assidua dei particolari naturalistici, proprio della prosa scientifica, sia irrobustita e proclamata da contrasti scenografici di luci e ombre.
Era tranquillamente azzurro il mare,
ma sotto a quella balza un sordo e fisso
muggito fean le spumanti acque amare;
ché un fiume, cui fu dal pendío prefisso
cieco sotterra il corso, ivi formava
co’ moti opposti, un vorticoso abisso.
Desío di rimirar qual s’aggirava
a spire il flutto, e tratto poi dal peso
perdeasi assorto nell’orribil cava,
me mal saggio avviò fin allo steso
dentro i profondi golfi orlo del masso,
e da incauto affrettar
così fui preso,
che sul confin io sdrucciolai col passo.
Dall’erta caddi, e un caprifico verde
afferrai sporto fuor del curvo sasso.
Gli spirti, che il terror fuga e diperde,
corsermi al cor lasciando in sé smarrita
l’alma, che il ragionar stupida perde.
In cotal guisa l’infelice vita
sospesa al troppo docil tronco stette
fra certa morte e vacillante aita.
Su l’onde in rotator circoli strette
fissai, ritorsi, chiusi le pupille
da un improvviso orror vinte e ristrette;
e tal ribrezzo misto a fredde stille
d’atro sudor m’irrigidì le avvinte
mani al sostegno mio, che quasi aprille
fra cento vane al mio pensier dipinte
idee, che furo in un momento accolte,
e cangiate, e riprese, e insiem rispinte.
Sconsigliato tentai colle rivolte
piante, e al dirupo fitte, arcando il dorso,
arrampicarmi alle pietrose volte;
ma il piè a toccar la roccia appena scorso
era, che il ritirai, dubbio qual fosse
peggior o il mio reo stato, o il mio soccorso;
perché all’arbor, che al grande urto si scosse,
temei col raddoppiar l’infausta leva
sveller affatto le radici smosse.
Grida tronche da fremiti io metteva,
che dai concavi tufi e dalle grotte
un eco spaventevol ripeteva.
Già dal forzato ceppo aspre e dirotte
sul corpo mi piovean ghiaie ed arene,
e l’ime barbe già scoppiavan rotte;
già l’alma ingombra avean larve sì piene
di morte, che pareami, anzi io sentia
le inghiottite acque entrar fin nelle vene;
perché il vortice infranto, che salía
in larghi spruzzi dai spumanti seni,
col ribalzato mar mi ricopria.
[...]
DELLA VANITà DELLA BELLEZZA TERRENA PER LA MORTE D'AMENNIRA
Tomba feral, ma nel coverchio aperta,
che parea da tremoto, o turbin fiero
pel diroccato suo colmo scoperta.
Vergate d’oro in un macigno nero
Tai brevi rilucean lugubri note:
sacro all’ottimo Dio massimo e vero.
Quella, che fia specchio all’età rimote
del vedovile onor, che afflitto or tace,
nota in pietade anche alle genti ignote,
Amennira (ahi che lessi!) oimè! qui giace.
Chiunque l’orme in queste sabbie imprime,
riposo preghi alla sciolt’Alma e pace.
Ristetti, inorridii, sdegnai le prime
incaute brame, che me spinser lasso
quelle a calcar piagge deserte ed ime;
poi vergogna ed amor al dubbio passo
diér moto sì, che lentamente salse
pe’ gradi, che cignean il tetro sasso:
ma ribrezzo in toccar l’urna m’assalse,
e la mia lena interna al terror mista
il gel nascente a superar non valse.
Tremando alfin afferrai l’orlo.
Ahi vista squallida,
lagrimevole, dogliosa,
Ahi d’umana beltade immagin trista!
Su letto di putredine schifosa
Giacca dal tempo nel suo morder forte
l’estinta spoglia avidamente rósa:
fitti i rai spenti entro l’occhiaje smorte,
guaste le labbra, aperto il petto, e Fanclie
gonfiate, e tinte di livida morte:
rigide e impallidite le man bianche,
dilacerato il grembo, e combattuto
dalle serpi non mai nell’ira stanche:
lezzo, noja ed orror quel, che rifiuto
fu degl’ingordi vermi, ed era in lei
la più vezzosa parte il cener muto.
Abborrii sì que’ lordi avanzi e rei,
che colla fronte addietro volta io mossi
giù dagl’infausti gradi i passi miei;
e colmo di stupor, quasi un Uom fossi
che sogna, e a sè chiede se vegli, o dorma
fra i dubbj dal sognar stesso in lui mossi,
a me chiedea: vera, o ingannevol forma
gli affascinati miei sensi delude?
Travidi? o pur del piè la stabil orma
lasciai su queste solitudin crude?
Chi ad Amennira alzò tomba sì grande
in terre d’ogni ancor vil pianta ignude?
O forse il nome addita altra, che spande
pari onor, Donna estinta, ed a me sembra,
che sue sieno le offerte altrui ghirlande?
Ma qual altra in virtude egual rassembra
a lei, che amore e morte in cor mi pose?
E di chi son quelle infelici membra?
Quelle son, che tu amasti, ella ripose.
[...]
Né mesto, ma tranquillo il viso grave,
e maggior dell’antica era l’immago.
La mente, che le larve oscure pave,
dal leggiadro sentì Spettro diffusa
maravigliosa in sé luce soave;
e dalla piena calma al core infusa
argomentò, che quella fosse un’Alma
O dal Ciel scesa, o in pace a viver usa.
Fiso io guardava l’impalpabil salma,
ch’ove avvien, che il vel doppio in sen trabocchi,
stretta avea l’una insieme all’altra palma,
e all’alto i lumi da pietà sì tocchi
volgea, che mai lassù non fùro affissi
nè più amorosi, né più amabil’occhi.
Tacendo essa, io pur tacqui, o non ardissi,
O me rendesse muto il mio stupore.
Confuso alfin ruppi il silenzio, e dissi:
O mia misera speme, e mio dolore,
fra le spolpate nel funereo seggio
Ossa tue carche di cotanto orrore, Amennira,
ed è ver ch’io ti riveggio?
O pur fra i sogni e i simulacri vani
del mio turbato immaginar ondeggio?
Da quali ignoti spazj, e alberghi arcani
degli astri, o degli abissi a me tu vieni
tratta di Morte dalle ferree mani?
Ma da qualunque a me sede ti meni
sì amico volo, ah! tu soave spiri
grazia, e fra il lutto ancor mi rassereni.
[...]
LE SORGENTI DELL'ARNO
L'autore, fra barocchismo e Preromanticismo, rende "orrendo" quel paese di Falterona, così prossimo alla mite estasi della Verna. "Crudo sasso" per altro, nella scenografia dantesca delle Stimmate. Stilemi naturalistici e lucreaziani a stento trovano un varco fra le reminiscenze arcadiche.
Vago di penetrar perchè Natura
non mai d’Arno gli umori appien consumi,
e incerto ancor, se del mar l’onda impura
per sotterranee ghiaje e schiusi dumi
feltrata salga alle montagne, e scenda
partita in rivi, ed in perpetui fiumi,
io l’erta ascesi d’una roccia orrenda,
che in mezzo all’Appennine Alpi nevose
le vie Tosche e l’Emilie avvien che fenda;
Ch’ivi scontrando ognor le rigogliose
acque scorrenti dall’origin prima
disvelarne credei le fonti ascose.
Stendeasi larga quell’alpestre cima
in scabri sì, ma rinverditi prati,
benché ad aspro soggetti indocil clima:
Questi d’argin informi, e di solcati
dorsi, e di gore, e d’ineguali fosse
in varie strane fogge eran vergati.
Cento scorgeansi in essi, ove serbosse
la pioggia, late vasche, altre già vote
d’acqua, altre sceme, altre ricolme e grosse.
Di là salii balze più eccelse, e note
solo ai rapaci augelli, e trovai boschi,
spelonche e abissi, in cui giaceano immote
le nevi e ghiacci, o splenda il giorno o infoschi,
non mai squagliati, perchè troppo inerte
È il sole a riscaldar quegli antri foschi.
Vidi in altre caverne al ciel scoperte
grondar le linfe dal pendio condotte
delle inzuppate, e ai raggi terre aperte;
e da più alte selve altre dirotte
fonti precipitando in tufi e in greppi
perdersi dentro a fesse rupi e a grotte.
Lassù pur il camrain fra schegge e ceppi
rósi, e pomici mai non viste altrove
tentai, né come il superassi io seppi;
e colà rimirai voragin nove,
e rappresi entro a quelle, e sciolti umori
del Libic’austro per l’estreme prove,
e campi squallidissimi peggiori
di quel ch’Uom finger possa, alberghi solo
di nevi e di gelate acque e d’orrori.
Da tai di tante piogge in erto suolo
serbatoi vasti un sovra l’altro stanti,
e dal vario del sol girar dal polo,
e dai venti fra lor vario-spiranti,
e dai vapor, che il sotterraneo foco
alza entro al monte, e striscian fuor grondanti,
argomentai, che il misto ordin del loco
a prestar atto sia continue l’onde
spinte in giù dalla scesa a poco a poco
O fra sterili sassi, o erbose sponde;
E il fiume tragga sol perenni l’acque
Dai montani antri e vasche, e non d’altronde.
[...]
Vedi anche: https://deisepolcriecimiteri.blogspot.com/2020/10/dallilluminismo-al-preromanticismo.html
Commento introduttivo a Leopardi e ai ''Piccoli Idilli''
Tratto da
è il più grande e infelice poeta del Romanticismo. Nacque a Recanati, nelle Marche, il 29 giugno 1798 dal conte Monaldo e dalla marchesa Adelaide Antici, intenta soprattutto a riassettare il dissestato patrimonio familiare. Alla madre dell'infelice poeta mancò la capacità di comprendere le esigenze e la delicatissima sensibilità del figlio, sul quale pesava l'oppressione di quel mondo chiuso. Il Leopardi trascorreva le sue giornate sui libri nella ricca biblioteca paterna; fu un'autodidatta: a 14 anni conosceva già il latino, il francese, il greco e l'ebraico. A 15 anni aveva già composto una "Storia dell'Astronomia" e a 16 un "Saggio sopra gli errori popolari degli antichi". Questi studi intensissimi gli fiaccarono per sempre il fisico: la deviazione della spina dorsale lo rese gobbo, la vista si indebolì.
Si volse presto alla poesia: appena 20enne, scrisse due canzoni, "All'Italia" e "Sopra il monumento di Dante". Nello stesso tempo la sua solitudine diveniva più amara e pensò di evadere dal mondo chiuso di Recanati, dove viveva. Tentò perciò di fuggire dalla casa paterna, ma fu scoperto e dovette rimanere nel "natio borgo selvaggio". E allora egli espresse in alcuni componimenti mirabili, che chiamò idilli, e la sua ansia di gloria, il suo desiderio di partecipazione alla vita, il suo dolore per i beni vagheggiati e perduti, la sua desolata rassegnazione. Nascono così "L'Infinito", "La sera del dì di festa", "Alla Luna", "La vita solitaria", "Alla primavera", "Ultimo canto di Saffo" e altri canti.
Finalmente nel 1822 poté recarsi a Roma, presso lo zio materno Carlo Antici; ma fu una grande delusione: anche lì la vita gli appariva vuota e misera. L'anno dopo tornò a Recanati e scrisse le "Operette Morali", nelle quali dimostra che l'universo è avvolto da un mistero impenetrabile e all'uomo è negata la possibilità di conoscere le ragioni del suo dolore. Dopo aver visitato Milano, sì recò a Pisa dove scrisse "A Silvia".
Le sofferenze fisiche tornarono presto a tormentarlo e dovette tornare a Recanati. "L'orrida solitudine del natio borgo selvaggio" richiamò al suo animo l'incanto delle illusioni della giovinezza, che egli cantò con nostalgia accorata in alcune altissime liriche: "Le ricordanze", "Il passero solitario", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio", "Canto notturno di un pastore errante per l'Asia". Morì a Napoli, il 14 giugno 1837; i suoi ultimi canti furono "La ginestra" e "Il tramonto della Luna".
L'infelicità del Leopardi si deve soprattutto ricercare nello squilibrio che c'era tra un mondo nuovo che la sua immaginazione fervidissima gli dipingeva ricco di valori ideali e la realtà che si rivelava inferiore ai sogni e dolorosa. Il sentimento del poeta oscilla sempre tra il sogno che gli fa vagheggiare come beni inenarrabili la gloria, la bellezza, l'amore, e la realtà che al lume della Ragione gli appare priva di valori ideali. Il Foscolo aveva superato il doloroso dissidio tra ideale e reale con la religione delle illusioni: per Foscolo, infatti, amore, bellezza, gloria, onore e poesia sono, è vero, illusioni, ma hanno un sicuro valore positivo, perché confortano l'animo del mortale e lo spronano ad un'azione eroica, la quale dà sempre valore alla vita.
Per il Leopardi, invece, le illusioni sono fantasmi, che spingono l'uomo verso la solitudine amara e desolata. La giovinezza accarezza, vagheggia questi fantasmi, li sente vivi e reali ed apre ad essi il cuore e la speranza; ma la giovinezza è breve e il sogno che essa accarezza urta presto contro l'"arido vero" che svuota le illusioni del loro fascino e svela che "la vita è male". E nel poeta sorge spontaneo il pianto sulle illusioni cadute, sul mondo dolcissimo della giovinezza, a cui l'anima sua sempre si volge.
Commento "Alla Luna": il canto "Alla Luna" insieme a "L'infinito", "La sera del dì di festa" e "La vita solitaria" fa parte dei Piccoli Idilli. Per "Idillio" si intende quel componimento poetico in cui vengono trattati argomenti tenui e delicati intorno alla vita campestre. Per Leopardi, invece, "Idillio" è contemplazione della natura, la quale non viene descritta nella sua realtà oggettiva ma è ritratta con sentimento individualissimo e con mesta sensibilità. Il Leopardi ha chiamato "Idilli" alcune delle sue liriche perché egli evoca le sue illusioni, il dolore, le speranze, i sogni rivivendoli insieme al paesaggio nel quale sono sorti; il suo è quel che si può chiamare "paesaggio-stato d'animo", un paesaggio che assume quel tono e quei colori che sono come l'eco suggestiva del sentimento e del canto che fluiscono nella sua anima; Chiorboli, commentando "Alla Luna", nota che è "poesia di paesaggio e di ricordo: il paesaggio suscita il ricordo e il ricordo il canto. Canto piano, sommesso, come di chi voglia sentirlo risonare solo nell'intimo dell'anima"
"Alla Luna"
O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l'anno, sovra questo colle (1)
io venia pien d'angoscia a rimirarti:
e tu pendevi (2) allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia (3), che travagliosa
era mia vita; ed è, né cangia stile,
o mia diletta luna. E pur mi giova
la ricordanza (4), e il noverar l'etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l'affanno duri! (5)
(1) è il monte Tabor, presso Recanati. è lo stesso monte dell'"Infinito"
(2) "Allora, un anno fa, tu, Luna, sovrastavi, come adesso, sulla selva vicino al monte; e come un anno fa, la rischiari ancora, con la tua luce candida."
Il poeta vezzeggia la Luna, definendola "graziosa" e "diletta". Anche nel "La sera del dì di festa" ci presenterà un altro suggestivo paesaggio lunare:
"Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna"
(3) "Ma il tuo volto appariva ai miei occhi ("luci") come velato da una nube e tremolante a causa del pianto che mi sorgeva sul ciglio perché la mia vita è infelice."
(4) "Eppure mi è grato ricordare e contare uno ad uno gli anni trascorsi nel dolore."
(5) "Oh come si presenta gradito nell'età giovanile, quando la speranza ha ancora un lungo corso, perché al giovane resta ancora da sperare, e la memoria è breve; come si presenta gradito, allora, il ricordo delle cose passate; il ricordo, infatti, è sempre dolce anche se richiama momenti tristi."
Commento all'"Infinito": è la primavera del 1819; poco fuori da Recanati si alza il monte Tabor e il poeta vi si reca, come tante altre volte, perché la solitudine interiore del suo animo si accorda con la solitudine del colle, sulla cima del quale una siepe impedisce di vedere tanta parte dell'ultimo orizzonte. Tutto intorno è silenzio, si avverte solo un lieve stormire di vento. Ma la fantasia del giovine Leopardi si leva oltre la siepe e si immerge in un mondo che non ha confini, nell'infinito, dove gli spazi sono interminati e i silenzi sovrumani e la quiete profondissima. Il cuore allora ha quasi un attimo di paura. Ma proprio quel lieve stormire di vento richiama il potere alla realtà limitata e dolorosa e fa sorgere ancora in lui l'ansia incontenibile verso gli orizzonti sconfinati, dove l'animo si quieta nell'oblio dei mali.
"L'Infinito"
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, (1)
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte (2) il guardo esclude.(3)
Ma sedendo e mirando (4), interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo (5); ove per poco
il cor non si spaura (6). E come il vento (7)
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce (8)
vo comparando (9): e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei (10). Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
(1) colle solitario. è il monte Tabor
(2) estremo orizzonte
(3) impedisce
(4) "Nonostante la siepe impedisca al mio sguardo di vedere tanta parte dell'estremo orizzonte, io sedendo su questo colle e fissando lo sguardo intensamente, verso la siepe."
(5) "Mi creo nella fantasia, immagino spazi sterminati e silenzi assoluti che mente umana non può concepire ("sovrumani") e quiete profondissima."
(6) e in questo infinito il cuore ha quasi un attimo di smarrimento
(7) appena
(8) del vento
(9) "comincio a paragonare"
(10) "e mi viene in mente l'eterno, l'età già trascorsa, l'età presente e viva e il suono di questa, che passa come il vento che odo stormire tra le piante"
Commento al "Passero Solitario": composto nel 1829, fa da proemio agli Idilli scritti dal '19 al '21. Il canto nasce e si modula nello sfondo primaverile di un passaggio sereno: è il 15 giugno: nella valle si diffonde il canto armonioso del passero solitario, che vive, per sua natura appartato, mentre gli altri uccelli si inebriano a gara nel volo che li porta liberi nel cielo. Il poeta, da un angolo remoto della campagna, mira la primavera che brilla nell'aria ma non prende parte alla gioia della natura, proprio come il passero solitario, che in disparte, sulla vetta del campanile, rimane estraneo all'allegria dei voli. I giovani, intanto, spensierati e in festa allietano le vie del paese, gli uccelli fanno mille giri per il cielo, ma le due creature pensose, il passero solitario e il poeta, non sanno accordarsi alla vita dei loro simili. L'incanto della Natura, tuttavia, penetra nell'animo e nasce nel poeta un sentimento sconsolato ma sereno, perché la consapevolezza del dolore accettato dona un senso di serenità, anche se infinitamente triste. Il canto si chiude con l'amara constatazione che se il passero non avrà a dolersi della solitudine, perché egli ubbidisce solo all'istinto, il poeta invece, quando gli anni peseranno su di lui, rimpiangerà i giorni della giovinezza: "Ahi pentirommi e spesso - ma sconsolato, volgerommi indietro". Rimpianto chiuso il suo, senza imprecazione, senza ribellione.
Momigliano così lo commenta: "E intanto i giorni tramontano e la beata gioventù vien meno. Quanta tristezza e quanta pacatezza! La malinconia si fa musica e la poesia sembra insieme dolore e conforto. Il lettore di questi versi chiari e meditativi come un tramonto, sente quale conforto fosse per Leopardi rispecchiare in essi la sua anima desolata... Pare veramente che quel canto di passero che erra sulla campagna finché non muore il giorno sia una cosa sola con il solitario e musicale rimpianto del poeta che passa la giovinezza pensando invano alle sue gioie, imprigionato dentro una timidezza fatale, rassegnato e desolato del destino che gli ha dato tanta anima per contemplare il giardino magico della giovinezza e gli ha sempre vietato di varcarne le soglie.
"Il passero solitario"
D'in su la vetta della torre antica (1)
passero solitario, alla campagna
cantando vai (2) finchè non more il giorno;
ed erra l'armonia per questa valle.
Primavera dintorno (3)
brilla nell'aria, e per li campi esulta,
sì ch'a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero ciel fan mille giri,
pur festeggiando il lor tempo migliore:
tu pensoso in disparte (4) il tutto miri;
non compagni, non voli,
non ti cal d'allegria (5), schivi gli spassi;
canti, e così trapassi
dell'anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
della novella età dolce famiglia,
e te german di giovinezza, amore,
sospiro acerbo de' provetti giorni
non curo io non so come; anzi da loro
quasi fuggo lontano;
quasi romito (6), e strano
al mio loco natio, (7)
passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch'omai cede alla sera, (8)
festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla, (9)
odi spesso un tonar di ferree canne, (10)
che rimbomba lontan di villa in villa. (11)
Tutta vestita a festa
la gioventù del loco
lascia le case, e per le vie si spande;
e mira ed è mirata, e in cor s'allegra.
Io solitario in questa
rimota parte alla campagna uscendo,
ogni diletto e gioco
indugio in altro tempo: e intanto il guardo
steso nell'aria aprica (12)
mi fere (13) il Sol che tra lontani monti,
dopo il giorno sereno,
cadendo si dilegua, e par che dica (14)
che la beata gioventù vien meno.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
del viver (15) che daranno a te le stelle,(16)
certo del tuo costume (17)
non ti dorrai; che di natura è frutto
ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
la detestata soglia
evitar non impetro,
quando muti questi occhi all'altrui core, (18)
e lor fia vòto il mondo, e il dì futuro
del dì presente più noioso e tetro,
che parrà di tal voglia?
Che di quest'anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
ma sconsolato, volgerommi indietro.
(1) è la torre o campanile della chiesa di sant'Agostino in Recanati.
(2) "avverti la vastità della campagna verso la quale è diretto e si spande il canto così melodioso del passero"
(3) Il passero è solo sulla vetta della torre, immobile, eppure la primavera brilla di luce e di colori e i campi esultano e sembrano ascoltare assorti quel canto melodioso
(4) notare il contrasto: gli altri uccelli fanno mille giri per il cielo, mentre tu, passero solitario, "stai in disparte"
(5) non ti importa di essere allegro come gli altri uccelli
(6) solitario
(7) estraneo addirittura al mio stesso luogo natio
(8) è il giorno di san Vito, patrono di Recanati
(9) di campana
(10) sono gli spari a salve dei fucili
(11) rimbomba di borgo in borgo
(12) aperta al sole, illuminata
(13) mi ferisce
(14) dileguandosi, il sole pare dire che tutte le cose di dileguano
(15) declino della vita, vecchiaia
(16) la sorte
(17) modo di vivere
(18) quando i miei occhi non parleranno più al cuore degli altri perché non vivificati dalla luce della giovinezza per essi il mondo sarà senza scopo e senza attrative
(19) il cuore del poeta tornerà indietro, ma invano agli anni della beata gioventù che avrà ormai perduta e le cui gioie non ha saputo godere
Commento alla "Sera del dì di festa": anche questo idillio, come "Il passero solitario", nasce sullo sfondo di un paesaggio dolce e sereno. è la sera di un giorno festivo: il 15 giugno 1820; la gioventù di Recanati ha festeggiato San Vito, patrono del paese. La notte è dolce, chiara e senza vento; il lume della luna si posa sopra i tetti e in mezzo ai campi e gli Appennini lontani appaiono nitidi e sereni. Ma quel terso passaggio lunare è contemplato dal poeta attraverso il velo dell'anima tormentata. Mentre la donna che gli aprì la piaga d'amore nel cuore dorme tranquilla nelle sue quiete stanze, il giovane effonde il suo lamento angoscioso sulla natura apparentemente dolce e serena. La notte è immersa nel silenzio e nel sonno: si ode soltanto il canto solitario di un artigiano. Quanto sono caduche le cose umane! Tutto passa, come quel canto che si perde nelle vie del paese. è passato il giorno festivo, succedono i giorni feriali, perfino la grandezza di Roma è tramontata; e tace anche l'angoscia di quell'amore presente che si dissolve nell'incanto della natura e nel silenzio della notte lunare.
"La sera del dì di festa"
Dolce e chiara è la notte e senza vento, (1)
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia,(2)
già tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce (3) la notturna lampa:
tu dormi, che t'accolse agevol sonno (4)
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e già non sai né pensi
quanta piaga m'apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
appare in vista, a salutar m'affaccio,
e l'antica natura onnipossente,
che mi fece all'affanno. (5) A te la speme
nego, mi disse, anche la speme; e d'altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da' trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non già, ch'io speri,
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
in così verde etate! Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell'artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov'è il suono
si que' popoli antichi? or dov'è il grido (6)
de' nostri avi famosi, e il grande impero
di quella Roma, e l'armi, e il fragorio
che n'andò per la terra e l'oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s'aspetta
bramosamente il dì festivo, or poscia
ch'egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s'udia per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core.
(1) l'incanto di questo paesaggio lunare ti scende nell'anima con la musica delle parole che hanno un tono sereno, chiaro, trasparente; la sensazione che provi è più spirituale che visiva.
(2) non sappiamo chi sia; forse è solo frutto della fantasia
(3) attraverso le imposte la lampada brilla solo qua e là nella notte, perché poche sono le case dove la gente è ancora sveglia
(4) il sonno della donna è agevole, cioè facile, perché essa non ha inquietudini ("e non ti morde cura alcuna")
(5) "Tu dormi; io invece saluto questo cielo che nella sua limpidezza si mostra benigno alla vista mentre in realtà, verso di me è tanto crudele e insieme al cielo saluto anche l'antica natura onnipotente che mi creò perché io soffrissi e mi ha negato anche la speranza"
(6) il tempo annulla ogni cosa
Commento a "Silvia": una giovane ventenne, Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, era morta di mal sottile nell'autunno del 1818. Il poeta aveva vagheggiato in questa fanciulla, che egli chiama Silvia, una bellezza e un amore ideali: le nere chiome, lo sguardo ridente e pudico, il canto dolcissimo di lei che si diffondeva nelle vie e nelle quiete stanze, avevano svegliato nel suo cuore un sentimento vago e indeterminato composto di quei sogni e di quelle speranze che solo la giovinezza può impersonare.
Nell'aprile del 1828, dieci anni dopo la morte di Teresa, il poeta rivive con tenera e casta commozione i sentimenti di allora: Silvia tesseva e il suo canto arrivava all'orecchio e al cuore del giovane poeta, il quale lasciava i libri per inseguire sogni, speranze e illusioni. Era il maggio odoroso, il sole batteva mite sulle vie e sui campi, verso oriente si stendeva l'Adriatico, verso occidente si alzavano gli Appennini. Ed affetti e speranze si confondevano in una rispondenza sentimentale, nel cuore di Silvia e del poeta e si intonavano alla natura, anch'essa così vaga e serena. Ma in autunno, con la morte di Silvia, si scioglie questo incanto. E nel cuore del poeta rimane solo compianto e rimpianto: rimpianto delle "nere chiome", "degli sguardi innamorati e schivi", del "caro immaginare" perché con Silvia si spensero la giovinezza e le speranze di Leopardi.
"A Silvia"
Silvia, rimembri ancora (1)
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa (2), il limitare
di gioventù salivi? (3)
Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili (4) intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare (5) il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte, (6)
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte, (7)
d'in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch'io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura, (8)
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo (9) combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d'amore
Anche peria fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovanezza. Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell'età mia nova,
mia lacrimata speme!
Questo è quel mondo? questi
i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi
onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell'umane genti?
All'apparir del vero (10)
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.
(1) Silvia è morta da dieci anni, ma il poeta si rivolge a lei come se fosse ancora viva perché essa è ancora presente nel suo cuore.
(2) Silvia è pensosa: forse ha il presentimento della sua morte
(3) stai per varcare la soglia della giovinezza.
(4) ai lavori femminili
(5) passare il giorno
(6) gli studi di letteratura e i libri sui quali faticavo
(7) ho consumato il mio tempo migliore sui libri
(8) Per Leopardi la Natura è madre di tutte le cose e quindi unica responsabile del nostro destino
(9) di tisi
(10) "tu, o misera speranza, cadesti quando io conobbi il senso della vita, nella sua amara realtà, quando cioè cadute le illusioni mi accorsi che la vita è solo dolore e infelicità e meta ultima rimane la morte fredda ed una tomba squallida, che tu, o speranza, mi mostravi da lontano"
Nota di Lunaria: è suggestivo anche rivedere questo passaggio così:
"tu, o misera Silvia, cadesti quando io conobbi il senso della vita, nella sua amara realtà, quando cioè cadute le illusioni mi accorsi che la vita è solo dolore e infelicità e meta ultima rimane la morte fredda ed una tomba squallida, che tu, o Silvia, mi mostravi da lontano"
Commento a "La quiete dopo la tempesta": anche questo idillio, come molti altri di Leopardi, si apre sullo sfondo del paesaggio recanatese, contemplato attraverso uno stato d'animo pensoso. Il concetto fondamentale del canto è che nell'uomo il dolore rimane uno stato naturale e quella gioia che talvolta ci è possibile godere, è da considerarsi tale in quanto cessazione del dolore. Osserviamo che dopo la tempesta la gioia penetra in tutti i cuori: gli uccelli tornano nel cielo "cantando e giocolando gli uni con gli altri"; la gallina ripete sulla via il suo verso; e mentre la campagna si sgombra delle nuvole e il sole sorride sulle stille della pioggia recente e gli Appennini si profilano chiari attraverso l'aria tersa, ecco l'artigiano che si affaccia allegro sull'uscio a guardare il cielo ancora umido, le donne che si affrettano a cogliere l'acqua piovana, l'erbivendolo che torna a ripetere il suo grido quotidiano lungo i sentieri. Questi istanti di gioia, però, sono nati tutti dall'affanno: durante la tempesta, quando le folgori, nembi e vento si erano scatenati sulla terra, anche colui che prima aborriva la vita cominciò a temere la morte. Ed allora cosa sono i doni e i diletti che la natura ci offre? "Gioia vana", osserva il poeta, "ch'è frutto del passato timore": gran guadagno è per l'uomo solo una breve sosta dal dolore e veramente felice può dirsi colui che la morte libera finalmente dalla pena.
"La quiete dopo la tempesta"
Passata è la tempesta: (1)
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna, (2)
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio
torna il lavoro usato.
L'artigiano a mirar l'umido cielo,
con l'opra in man, cantando,
fassi (3) in su l'uscio; a prova (4)
vien fuor la femminetta a còr dell'acqua
della novella piova;(5)
e l'erbaiuol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passegger che il suo cammin ripiglia.
Si rallegra ogni core.
Sì dolce, sì gradita
Quand'è, com'or, la vita?
Quando con tanto amore
l'uomo a' suoi studi intende?
O torna all'opre? o cosa nova imprende? (6)
Quando de' mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d'affanno;(7)
gioia vana, ch'è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudàr le genti e palpitàr, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.
O natura cortese, (8)
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge (9): e di piacer, quel tanto
che per mostro (10) e miracolo talvolta
nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni; assai felice
se respirar ti lice (11)
d'alcun dolor: beata
se te d'ogni dolor morte risana.
(1) Il poeta avverte subito la gioia che si diffonde intorno; dopo farà le sue considerazioni pensose, ma intanto coglie la gioia negli uccelli.
(2) dal denso velo di nebbia piovigginosa.
(3) si fa, si affaccia.
(4) a gara
(5) a raccogliere l'acqua della pioggia recente.
(6) incomincia quasi con gioia.
(7) è questo il tema centrale del canto: gli uccelli, le donne del paese, l'artigiano, l'erbivendolo, tutte le creature hanno aperto il loro cuore alla letizia, ma solo dopo che la tempesta li ha atterriti. Quindi il piacere nasce dal dolore e perciò non è una qualità positiva, ma una gioia vana, che è frutto "del passato timore".
(8) "cortese" ha valore ironico.
(9) il piacere è figlio dell'affanno, ma il dolore nasce spontaneamente, è uno stato naturale dell'uomo.
(10) e quel poco di piacere che talvolta, quasi per prodigio (mostro) o miracolo, nasce dal cessare del dolore, è veramente un grande acquisto.
(11) "Puoi stimarti felice se appena ti è concesso un po' di respiro da qualche dolore"
(12) "Puoi considerarti beato se la morte ti libera da tutti i mali"
Commento a "Il sabato del villaggio": ancora un quadro di vita paesana e dei più suggestivi. Nasce nell'atmosfera di festa che si diffonde nell'aria e nei cuori la sera del sabato. Il sole sta per tramontare: la contadinella torna alla campagna col suo fascio di erba sul capo e il mazzolino di fiori per potersi ornare l'indomani del giorno festivo; l'attesa gioiosa della festa si rispecchia anche nel viso della vecchiarella, che continua a filare rivolta verso il sole che tramonta rievocando i giorni della giovinezza, quando anche ella si ornava per andare a danzare con i coetanei. Intanto scende la sera: la luna diffonde la sua bianca luce e la campana annuncia la festa imminente: alle grida dei fanciulli che giocano sulla piazzola, si accompagna il fischiare dello zappatore che torna alla sua parca mensa. E quando la notte è già alta è tutt'intorno è silenzio e pace, s'ode ancora un frequente picchiare di martello: è il legnaiolo che si affretta a finire il lavoro prima che spunti l'alba: ma lavora in letizia perché poi anche lui potrà finalmente riposare. La notazioni paesistiche, nelle quali si distende questa nota di gioia, sono semplici, limpide, serene, come le anime di quel piccolo mondo che attende il giorno festivo. Ma già il poeta ha il presentimento della pena: egli sa che l'indomani le ore recheranno tristezza e noia, perché la gioia è solo nell'attesa del bene, il quale, appena raggiunto, si rivelerà vuoto. E così l'atmosfera festosa della vigilia si risolve nel rimpianto della gioia già passata prima ancora che sia goduta. Il poeta tuttavia non vuole togliere l'illusione al cuore del fanciullo che gioca e sogna e gli augura che la giovinezza tardi per lui a venire, perché quando egli sarà uomo vedrà cadere l'incanto che ha sognato.
"Il sabato del villaggio"
La donzelletta vien dalla campagna,
in sul calar del sole,
col suo fascio dell'erbe; e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,
onde, siccome suole,
ornare ella si appresta (1)
dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno; (2)
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dì della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch'ebbe compagni dell'età più bella.
già tutta l'aria imbruna, (3)
torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre
giù da' colli e da' tetti, (4)
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore:
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.
Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l'altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s'affretta, e s'adopra
di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba.(5)
Questo di sette è il più gradito giorno, (6)
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l'ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita (7)
è come un giorno d'allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
(1) con la quale si prepara
(2) col viso rivolto verso quella parte dove il sole sta per tramontare. La luce dell'ultimo sole illumina il viso della vecchiarella che partecipa alla diffusa gioia del sabato e rievoca, senza malinconia, la sua giovinezza lontana.
(3) Il sole è già tramontato
(4) sembra che le ombre scendano dai colli e dai tetti
(5) si ingegna di terminare il suo lavoro
(6) è il motivo centrale del canto: il sabato è il più caro di tutti i giorni, perché pieno di speranza e di gioia. E domani? domani, domenica, le ore porteranno tristezza e noia. La felicità è nell'attesa.
(7) la tua fanciullezza.
Commento a "Il tramonto della luna"
Primavera del 1836: il Leopardi è ospite dell'amico Antonio Ranieri in una villa di Torre del Greco, alle falde del Vesuvio. In questo luogo incantevole egli scrive il suo ultimo canto che si apre con un paesaggio - stato d'animo, il più desolato. La luna, che con la sua luce ha inargentato le campagne e le acque volge al tramonto e lontano tra le luci e le ombre create dalla semioscurità, sorgono forme indeterminate e incerte; poi quando essa cade del tutto, anche le ombre spariscono, il buio completo incombe sulla valle e sui monti e il canto mesto del carrettiere saluta la luce che fino allora lo aveva accompagnato lungo il cammino. Anche la giovinezza, che con le dolci illusioni ha allietato la vita mortale, si dilegua come la luna; e con essa si sciolgono le dilettose immagini. Ma sulle colline e nelle valli tornerà presto a splendere l'alba; per l'uomo, svanita la bella giovinezza, non ci sarà più sorriso d'altra luce o di altra aurora. E su di lui incomberà il più grave di tutti i mali: la vecchiaia. E dopo la vecchiaia, la morte.
In questo canto Leopardi esprime il suo malinconico addio alla giovinezza che si dissolve rapida ed alla vita che egli sente venir meno; si dice anzi che gli ultimi versi siano stati dettati al Ranieri due ore prima che il poeta chiudesse gli occhi e il cuore alle vie dorate, agli orti, al "primo degli augelli sussurro", alle montagne serene, alla notte dolce e chiara senza vento, ai suggestivi paesaggi lunari che anche nelle altre liriche egli aveva rimpianto, ma con un sentimento meno desolato di quello espresso in "Tramonto della luna"
"Tramonto della Luna"
Quale in notte solinga, (1)
sovra campagne inargentate ed acque,
là 've zefiro aleggia,
e mille vaghi aspetti
e ingannevoli obbietti
fingon l'ombre lontane
infra l'onde tranquille
e rami e siepi e collinette e ville;
giunta al confin del cielo,
dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno
nell'infinito seno
scende la luna; e si scolora il mondo;
spariscon l'ombre, ed una
oscurità la valle e il monte imbruna;
orba la notte resta, (2)
e cantando, con mesta melodia,
l'estremo albor della fuggente luce,
che dianzi gli fu duce,
saluta il carrettier dalla sua via; (3)
tal si dilegua, e tale
lascia l'età mortale
la giovinezza. In fuga
van l'ombre e le sembianze
dei dilettosi inganni; (4) e vengon meno
le lontane speranze,
ove s'appoggia la mortal natura.
Abbandonata, oscura
resta la vita. In lei porgendo il guardo,
cerca il confuso viatore invano
del cammin lungo che avanzar si sente
meta o ragione; e vede
che a sé l'umana sede,
esso a lei veramente è fatto estrano.
Troppo felice e lieta
nostra misera sorte
parve lassù, se il giovanile stato,
dove ogni ben di mille pene è frutto,
durasse tutto della vita il corso. (5)
Troppo mite decreto
quel che sentenzia ogni animale a morte,
s'anco mezza la via
lor non si desse in pria
della terribil morte assai più dura. (6)
D'intelletti immortali
degno trovato, estremo
di tutti i mali, ritrovàr gli eterni
la vecchiezza, ove fosse
incolume il desio, la speme estinta,
secche le fonti del piacer, le pene
maggiori sempre, e non più dato il bene. (7)
Voi, collinette e piagge,
caduto lo splendor che all'occidente
inargentava della notte il velo,
orfane ancor gran tempo
non resterete; (8) che dall'altra parte
tosto vedrete il cielo
imbiancar novamente, e sorger l'alba:
alla qual poscia seguitando il sole,
e folgorando intorno
con sue fiamme possenti,
di lucidi torrenti
inonderà con voi gli eterei campi.
Ma la vita mortal, poi che la bella
giovinezza sparì, non si colora
d'altra luce giammai, né d'altra aurora.
Vedova è insino al fine; ed alla notte
che l'altre etadi oscura,
segno poser gli Dei la sepoltura. (9)
(1) Come in una notte solitaria la luna, giunta all'orizzonte, dietro gli Appennini o le Alpi oppure nel seno infinito del Tirreno, scende sopra le campagne ed acque inargentate, dove spira un vento leggero di primavera (Zefiro) e le ombre lontane formano (fingono) mille aspetti indeterminati (vaghi) ed illusori (ingannevoli) fra le acque tranquille e fra i rami, le siepi, le collinette e le ville e il mondo si scolora.
(2) La notte, dopo il tramonto della luna, resta priva di luce.
(3) Il carrettiere saluta con la melodia mesta del suo canto l'ultimo chiarore lunare che ora va dileguandosi (fuggente).
Il paesaggio leopardiano assume il tono e i colori dello stato d'animo del poeta, il quale ormai sente prossima la tanto invocata morte. Egli, di questa notte, coglie l'atmosfera desolata così aderente alla sua esperienza di vita: l'ultima luce della luna si posa sopra i campi e sui colli; ad essa succede un buio profondo che sommerge i mille vaghi aspetti della natura. Lo stesso avviene nell'uomo: la giovinezza con gli ameni inganni sfocia e si dissolve nella vecchiaia. Quanta solitudine nel cielo dopo il tramonto della luna e quanta solitudine nell'anima dopo il tramonto della giovinezza!
(4) I sogni e i fantasmi creati dalle piacevoli illusioni giovanili.
(5) Nella vita umana l'unica età dove si gode di qualche bene è la giovinezza: ma gli Dei vollero togliere agli uomini anche la giovinezza, assegnandogli un male peggiore anche della morte: la vecchiaia.
(6) Se prima della morte (in pria) non si concedesse loro anche quell'altra metà della vita (mezza la via) cioè la vecchiezza.
(7) Intatto il desiderio, morta la speranza di appagarlo.
(8) Prive di luce: alla notte succederà l'alba. Torna l'alba, ma non le illusioni della giovinezza.
(9) Ed alle tenebre che oscurano le altre età dell'uomo, cioè la maturità e la vecchiaia, non la giovinezza - gli Dei posero come meta (segno) la sepoltura. Quanta desolazione, in questa chiusa!
è il più grande e infelice poeta del Romanticismo. Nacque a Recanati, nelle Marche, il 29 giugno 1798 dal conte Monaldo e dalla marchesa Adelaide Antici, intenta soprattutto a riassettare il dissestato patrimonio familiare. Alla madre dell'infelice poeta mancò la capacità di comprendere le esigenze e la delicatissima sensibilità del figlio, sul quale pesava l'oppressione di quel mondo chiuso. Il Leopardi trascorreva le sue giornate sui libri nella ricca biblioteca paterna; fu un'autodidatta: a 14 anni conosceva già il latino, il francese, il greco e l'ebraico. A 15 anni aveva già composto una "Storia dell'Astronomia" e a 16 un "Saggio sopra gli errori popolari degli antichi". Questi studi intensissimi gli fiaccarono per sempre il fisico: la deviazione della spina dorsale lo rese gobbo, la vista si indebolì.
Si volse presto alla poesia: appena 20enne, scrisse due canzoni, "All'Italia" e "Sopra il monumento di Dante". Nello stesso tempo la sua solitudine diveniva più amara e pensò di evadere dal mondo chiuso di Recanati, dove viveva. Tentò perciò di fuggire dalla casa paterna, ma fu scoperto e dovette rimanere nel "natio borgo selvaggio". E allora egli espresse in alcuni componimenti mirabili, che chiamò idilli, e la sua ansia di gloria, il suo desiderio di partecipazione alla vita, il suo dolore per i beni vagheggiati e perduti, la sua desolata rassegnazione. Nascono così "L'Infinito", "La sera del dì di festa", "Alla Luna", "La vita solitaria", "Alla primavera", "Ultimo canto di Saffo" e altri canti.
Finalmente nel 1822 poté recarsi a Roma, presso lo zio materno Carlo Antici; ma fu una grande delusione: anche lì la vita gli appariva vuota e misera. L'anno dopo tornò a Recanati e scrisse le "Operette Morali", nelle quali dimostra che l'universo è avvolto da un mistero impenetrabile e all'uomo è negata la possibilità di conoscere le ragioni del suo dolore. Dopo aver visitato Milano, sì recò a Pisa dove scrisse "A Silvia".
Le sofferenze fisiche tornarono presto a tormentarlo e dovette tornare a Recanati. "L'orrida solitudine del natio borgo selvaggio" richiamò al suo animo l'incanto delle illusioni della giovinezza, che egli cantò con nostalgia accorata in alcune altissime liriche: "Le ricordanze", "Il passero solitario", "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio", "Canto notturno di un pastore errante per l'Asia". Morì a Napoli, il 14 giugno 1837; i suoi ultimi canti furono "La ginestra" e "Il tramonto della Luna".
L'infelicità del Leopardi si deve soprattutto ricercare nello squilibrio che c'era tra un mondo nuovo che la sua immaginazione fervidissima gli dipingeva ricco di valori ideali e la realtà che si rivelava inferiore ai sogni e dolorosa. Il sentimento del poeta oscilla sempre tra il sogno che gli fa vagheggiare come beni inenarrabili la gloria, la bellezza, l'amore, e la realtà che al lume della Ragione gli appare priva di valori ideali. Il Foscolo aveva superato il doloroso dissidio tra ideale e reale con la religione delle illusioni: per Foscolo, infatti, amore, bellezza, gloria, onore e poesia sono, è vero, illusioni, ma hanno un sicuro valore positivo, perché confortano l'animo del mortale e lo spronano ad un'azione eroica, la quale dà sempre valore alla vita.
Per il Leopardi, invece, le illusioni sono fantasmi, che spingono l'uomo verso la solitudine amara e desolata. La giovinezza accarezza, vagheggia questi fantasmi, li sente vivi e reali ed apre ad essi il cuore e la speranza; ma la giovinezza è breve e il sogno che essa accarezza urta presto contro l'"arido vero" che svuota le illusioni del loro fascino e svela che "la vita è male". E nel poeta sorge spontaneo il pianto sulle illusioni cadute, sul mondo dolcissimo della giovinezza, a cui l'anima sua sempre si volge.
Commento "Alla Luna": il canto "Alla Luna" insieme a "L'infinito", "La sera del dì di festa" e "La vita solitaria" fa parte dei Piccoli Idilli. Per "Idillio" si intende quel componimento poetico in cui vengono trattati argomenti tenui e delicati intorno alla vita campestre. Per Leopardi, invece, "Idillio" è contemplazione della natura, la quale non viene descritta nella sua realtà oggettiva ma è ritratta con sentimento individualissimo e con mesta sensibilità. Il Leopardi ha chiamato "Idilli" alcune delle sue liriche perché egli evoca le sue illusioni, il dolore, le speranze, i sogni rivivendoli insieme al paesaggio nel quale sono sorti; il suo è quel che si può chiamare "paesaggio-stato d'animo", un paesaggio che assume quel tono e quei colori che sono come l'eco suggestiva del sentimento e del canto che fluiscono nella sua anima; Chiorboli, commentando "Alla Luna", nota che è "poesia di paesaggio e di ricordo: il paesaggio suscita il ricordo e il ricordo il canto. Canto piano, sommesso, come di chi voglia sentirlo risonare solo nell'intimo dell'anima"
"Alla Luna"
O graziosa luna, io mi rammento
che, or volge l'anno, sovra questo colle (1)
io venia pien d'angoscia a rimirarti:
e tu pendevi (2) allor su quella selva
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia (3), che travagliosa
era mia vita; ed è, né cangia stile,
o mia diletta luna. E pur mi giova
la ricordanza (4), e il noverar l'etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l'affanno duri! (5)
(1) è il monte Tabor, presso Recanati. è lo stesso monte dell'"Infinito"
(2) "Allora, un anno fa, tu, Luna, sovrastavi, come adesso, sulla selva vicino al monte; e come un anno fa, la rischiari ancora, con la tua luce candida."
Il poeta vezzeggia la Luna, definendola "graziosa" e "diletta". Anche nel "La sera del dì di festa" ci presenterà un altro suggestivo paesaggio lunare:
"Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna"
(3) "Ma il tuo volto appariva ai miei occhi ("luci") come velato da una nube e tremolante a causa del pianto che mi sorgeva sul ciglio perché la mia vita è infelice."
(4) "Eppure mi è grato ricordare e contare uno ad uno gli anni trascorsi nel dolore."
(5) "Oh come si presenta gradito nell'età giovanile, quando la speranza ha ancora un lungo corso, perché al giovane resta ancora da sperare, e la memoria è breve; come si presenta gradito, allora, il ricordo delle cose passate; il ricordo, infatti, è sempre dolce anche se richiama momenti tristi."
Commento all'"Infinito": è la primavera del 1819; poco fuori da Recanati si alza il monte Tabor e il poeta vi si reca, come tante altre volte, perché la solitudine interiore del suo animo si accorda con la solitudine del colle, sulla cima del quale una siepe impedisce di vedere tanta parte dell'ultimo orizzonte. Tutto intorno è silenzio, si avverte solo un lieve stormire di vento. Ma la fantasia del giovine Leopardi si leva oltre la siepe e si immerge in un mondo che non ha confini, nell'infinito, dove gli spazi sono interminati e i silenzi sovrumani e la quiete profondissima. Il cuore allora ha quasi un attimo di paura. Ma proprio quel lieve stormire di vento richiama il potere alla realtà limitata e dolorosa e fa sorgere ancora in lui l'ansia incontenibile verso gli orizzonti sconfinati, dove l'animo si quieta nell'oblio dei mali.
"L'Infinito"
Sempre caro mi fu quest'ermo colle, (1)
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte (2) il guardo esclude.(3)
Ma sedendo e mirando (4), interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo (5); ove per poco
il cor non si spaura (6). E come il vento (7)
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce (8)
vo comparando (9): e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei (10). Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.
(1) colle solitario. è il monte Tabor
(2) estremo orizzonte
(3) impedisce
(4) "Nonostante la siepe impedisca al mio sguardo di vedere tanta parte dell'estremo orizzonte, io sedendo su questo colle e fissando lo sguardo intensamente, verso la siepe."
(5) "Mi creo nella fantasia, immagino spazi sterminati e silenzi assoluti che mente umana non può concepire ("sovrumani") e quiete profondissima."
(6) e in questo infinito il cuore ha quasi un attimo di smarrimento
(7) appena
(8) del vento
(9) "comincio a paragonare"
(10) "e mi viene in mente l'eterno, l'età già trascorsa, l'età presente e viva e il suono di questa, che passa come il vento che odo stormire tra le piante"
Commento al "Passero Solitario": composto nel 1829, fa da proemio agli Idilli scritti dal '19 al '21. Il canto nasce e si modula nello sfondo primaverile di un passaggio sereno: è il 15 giugno: nella valle si diffonde il canto armonioso del passero solitario, che vive, per sua natura appartato, mentre gli altri uccelli si inebriano a gara nel volo che li porta liberi nel cielo. Il poeta, da un angolo remoto della campagna, mira la primavera che brilla nell'aria ma non prende parte alla gioia della natura, proprio come il passero solitario, che in disparte, sulla vetta del campanile, rimane estraneo all'allegria dei voli. I giovani, intanto, spensierati e in festa allietano le vie del paese, gli uccelli fanno mille giri per il cielo, ma le due creature pensose, il passero solitario e il poeta, non sanno accordarsi alla vita dei loro simili. L'incanto della Natura, tuttavia, penetra nell'animo e nasce nel poeta un sentimento sconsolato ma sereno, perché la consapevolezza del dolore accettato dona un senso di serenità, anche se infinitamente triste. Il canto si chiude con l'amara constatazione che se il passero non avrà a dolersi della solitudine, perché egli ubbidisce solo all'istinto, il poeta invece, quando gli anni peseranno su di lui, rimpiangerà i giorni della giovinezza: "Ahi pentirommi e spesso - ma sconsolato, volgerommi indietro". Rimpianto chiuso il suo, senza imprecazione, senza ribellione.
Momigliano così lo commenta: "E intanto i giorni tramontano e la beata gioventù vien meno. Quanta tristezza e quanta pacatezza! La malinconia si fa musica e la poesia sembra insieme dolore e conforto. Il lettore di questi versi chiari e meditativi come un tramonto, sente quale conforto fosse per Leopardi rispecchiare in essi la sua anima desolata... Pare veramente che quel canto di passero che erra sulla campagna finché non muore il giorno sia una cosa sola con il solitario e musicale rimpianto del poeta che passa la giovinezza pensando invano alle sue gioie, imprigionato dentro una timidezza fatale, rassegnato e desolato del destino che gli ha dato tanta anima per contemplare il giardino magico della giovinezza e gli ha sempre vietato di varcarne le soglie.
"Il passero solitario"
D'in su la vetta della torre antica (1)
passero solitario, alla campagna
cantando vai (2) finchè non more il giorno;
ed erra l'armonia per questa valle.
Primavera dintorno (3)
brilla nell'aria, e per li campi esulta,
sì ch'a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero ciel fan mille giri,
pur festeggiando il lor tempo migliore:
tu pensoso in disparte (4) il tutto miri;
non compagni, non voli,
non ti cal d'allegria (5), schivi gli spassi;
canti, e così trapassi
dell'anno e di tua vita il più bel fiore.
Oimè, quanto somiglia
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
della novella età dolce famiglia,
e te german di giovinezza, amore,
sospiro acerbo de' provetti giorni
non curo io non so come; anzi da loro
quasi fuggo lontano;
quasi romito (6), e strano
al mio loco natio, (7)
passo del viver mio la primavera.
Questo giorno ch'omai cede alla sera, (8)
festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla, (9)
odi spesso un tonar di ferree canne, (10)
che rimbomba lontan di villa in villa. (11)
Tutta vestita a festa
la gioventù del loco
lascia le case, e per le vie si spande;
e mira ed è mirata, e in cor s'allegra.
Io solitario in questa
rimota parte alla campagna uscendo,
ogni diletto e gioco
indugio in altro tempo: e intanto il guardo
steso nell'aria aprica (12)
mi fere (13) il Sol che tra lontani monti,
dopo il giorno sereno,
cadendo si dilegua, e par che dica (14)
che la beata gioventù vien meno.
Tu, solingo augellin, venuto a sera
del viver (15) che daranno a te le stelle,(16)
certo del tuo costume (17)
non ti dorrai; che di natura è frutto
ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
la detestata soglia
evitar non impetro,
quando muti questi occhi all'altrui core, (18)
e lor fia vòto il mondo, e il dì futuro
del dì presente più noioso e tetro,
che parrà di tal voglia?
Che di quest'anni miei? che di me stesso?
Ahi pentirommi, e spesso,
ma sconsolato, volgerommi indietro.
(1) è la torre o campanile della chiesa di sant'Agostino in Recanati.
(2) "avverti la vastità della campagna verso la quale è diretto e si spande il canto così melodioso del passero"
(3) Il passero è solo sulla vetta della torre, immobile, eppure la primavera brilla di luce e di colori e i campi esultano e sembrano ascoltare assorti quel canto melodioso
(4) notare il contrasto: gli altri uccelli fanno mille giri per il cielo, mentre tu, passero solitario, "stai in disparte"
(5) non ti importa di essere allegro come gli altri uccelli
(6) solitario
(7) estraneo addirittura al mio stesso luogo natio
(8) è il giorno di san Vito, patrono di Recanati
(9) di campana
(10) sono gli spari a salve dei fucili
(11) rimbomba di borgo in borgo
(12) aperta al sole, illuminata
(13) mi ferisce
(14) dileguandosi, il sole pare dire che tutte le cose di dileguano
(15) declino della vita, vecchiaia
(16) la sorte
(17) modo di vivere
(18) quando i miei occhi non parleranno più al cuore degli altri perché non vivificati dalla luce della giovinezza per essi il mondo sarà senza scopo e senza attrative
(19) il cuore del poeta tornerà indietro, ma invano agli anni della beata gioventù che avrà ormai perduta e le cui gioie non ha saputo godere
Commento alla "Sera del dì di festa": anche questo idillio, come "Il passero solitario", nasce sullo sfondo di un paesaggio dolce e sereno. è la sera di un giorno festivo: il 15 giugno 1820; la gioventù di Recanati ha festeggiato San Vito, patrono del paese. La notte è dolce, chiara e senza vento; il lume della luna si posa sopra i tetti e in mezzo ai campi e gli Appennini lontani appaiono nitidi e sereni. Ma quel terso passaggio lunare è contemplato dal poeta attraverso il velo dell'anima tormentata. Mentre la donna che gli aprì la piaga d'amore nel cuore dorme tranquilla nelle sue quiete stanze, il giovane effonde il suo lamento angoscioso sulla natura apparentemente dolce e serena. La notte è immersa nel silenzio e nel sonno: si ode soltanto il canto solitario di un artigiano. Quanto sono caduche le cose umane! Tutto passa, come quel canto che si perde nelle vie del paese. è passato il giorno festivo, succedono i giorni feriali, perfino la grandezza di Roma è tramontata; e tace anche l'angoscia di quell'amore presente che si dissolve nell'incanto della natura e nel silenzio della notte lunare.
"La sera del dì di festa"
Dolce e chiara è la notte e senza vento, (1)
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia,(2)
già tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce (3) la notturna lampa:
tu dormi, che t'accolse agevol sonno (4)
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e già non sai né pensi
quanta piaga m'apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
appare in vista, a salutar m'affaccio,
e l'antica natura onnipossente,
che mi fece all'affanno. (5) A te la speme
nego, mi disse, anche la speme; e d'altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da' trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non già, ch'io speri,
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
in così verde etate! Ahi, per la via
odo non lunge il solitario canto
dell'artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dì festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov'è il suono
si que' popoli antichi? or dov'è il grido (6)
de' nostri avi famosi, e il grande impero
di quella Roma, e l'armi, e il fragorio
che n'andò per la terra e l'oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s'aspetta
bramosamente il dì festivo, or poscia
ch'egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s'udia per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core.
(1) l'incanto di questo paesaggio lunare ti scende nell'anima con la musica delle parole che hanno un tono sereno, chiaro, trasparente; la sensazione che provi è più spirituale che visiva.
(2) non sappiamo chi sia; forse è solo frutto della fantasia
(3) attraverso le imposte la lampada brilla solo qua e là nella notte, perché poche sono le case dove la gente è ancora sveglia
(4) il sonno della donna è agevole, cioè facile, perché essa non ha inquietudini ("e non ti morde cura alcuna")
(5) "Tu dormi; io invece saluto questo cielo che nella sua limpidezza si mostra benigno alla vista mentre in realtà, verso di me è tanto crudele e insieme al cielo saluto anche l'antica natura onnipotente che mi creò perché io soffrissi e mi ha negato anche la speranza"
(6) il tempo annulla ogni cosa
Commento a "Silvia": una giovane ventenne, Teresa Fattorini, figlia del cocchiere di casa Leopardi, era morta di mal sottile nell'autunno del 1818. Il poeta aveva vagheggiato in questa fanciulla, che egli chiama Silvia, una bellezza e un amore ideali: le nere chiome, lo sguardo ridente e pudico, il canto dolcissimo di lei che si diffondeva nelle vie e nelle quiete stanze, avevano svegliato nel suo cuore un sentimento vago e indeterminato composto di quei sogni e di quelle speranze che solo la giovinezza può impersonare.
Nell'aprile del 1828, dieci anni dopo la morte di Teresa, il poeta rivive con tenera e casta commozione i sentimenti di allora: Silvia tesseva e il suo canto arrivava all'orecchio e al cuore del giovane poeta, il quale lasciava i libri per inseguire sogni, speranze e illusioni. Era il maggio odoroso, il sole batteva mite sulle vie e sui campi, verso oriente si stendeva l'Adriatico, verso occidente si alzavano gli Appennini. Ed affetti e speranze si confondevano in una rispondenza sentimentale, nel cuore di Silvia e del poeta e si intonavano alla natura, anch'essa così vaga e serena. Ma in autunno, con la morte di Silvia, si scioglie questo incanto. E nel cuore del poeta rimane solo compianto e rimpianto: rimpianto delle "nere chiome", "degli sguardi innamorati e schivi", del "caro immaginare" perché con Silvia si spensero la giovinezza e le speranze di Leopardi.
"A Silvia"
Silvia, rimembri ancora (1)
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa (2), il limitare
di gioventù salivi? (3)
Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all'opre femminili (4) intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
così menare (5) il giorno.
Io gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte, (6)
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte, (7)
d'in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch'io sentiva in seno.
Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
E tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura, (8)
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?
Tu pria che l'erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo (9) combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dì festivi
ragionavan d'amore
Anche peria fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negaro i fati
la giovanezza. Ahi come,
come passata sei,
cara compagna dell'età mia nova,
mia lacrimata speme!
Questo è quel mondo? questi
i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi
onde cotanto ragionammo insieme?
Questa la sorte dell'umane genti?
All'apparir del vero (10)
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.
(1) Silvia è morta da dieci anni, ma il poeta si rivolge a lei come se fosse ancora viva perché essa è ancora presente nel suo cuore.
(2) Silvia è pensosa: forse ha il presentimento della sua morte
(3) stai per varcare la soglia della giovinezza.
(4) ai lavori femminili
(5) passare il giorno
(6) gli studi di letteratura e i libri sui quali faticavo
(7) ho consumato il mio tempo migliore sui libri
(8) Per Leopardi la Natura è madre di tutte le cose e quindi unica responsabile del nostro destino
(9) di tisi
(10) "tu, o misera speranza, cadesti quando io conobbi il senso della vita, nella sua amara realtà, quando cioè cadute le illusioni mi accorsi che la vita è solo dolore e infelicità e meta ultima rimane la morte fredda ed una tomba squallida, che tu, o speranza, mi mostravi da lontano"
Nota di Lunaria: è suggestivo anche rivedere questo passaggio così:
"tu, o misera Silvia, cadesti quando io conobbi il senso della vita, nella sua amara realtà, quando cioè cadute le illusioni mi accorsi che la vita è solo dolore e infelicità e meta ultima rimane la morte fredda ed una tomba squallida, che tu, o Silvia, mi mostravi da lontano"
Commento a "La quiete dopo la tempesta": anche questo idillio, come molti altri di Leopardi, si apre sullo sfondo del paesaggio recanatese, contemplato attraverso uno stato d'animo pensoso. Il concetto fondamentale del canto è che nell'uomo il dolore rimane uno stato naturale e quella gioia che talvolta ci è possibile godere, è da considerarsi tale in quanto cessazione del dolore. Osserviamo che dopo la tempesta la gioia penetra in tutti i cuori: gli uccelli tornano nel cielo "cantando e giocolando gli uni con gli altri"; la gallina ripete sulla via il suo verso; e mentre la campagna si sgombra delle nuvole e il sole sorride sulle stille della pioggia recente e gli Appennini si profilano chiari attraverso l'aria tersa, ecco l'artigiano che si affaccia allegro sull'uscio a guardare il cielo ancora umido, le donne che si affrettano a cogliere l'acqua piovana, l'erbivendolo che torna a ripetere il suo grido quotidiano lungo i sentieri. Questi istanti di gioia, però, sono nati tutti dall'affanno: durante la tempesta, quando le folgori, nembi e vento si erano scatenati sulla terra, anche colui che prima aborriva la vita cominciò a temere la morte. Ed allora cosa sono i doni e i diletti che la natura ci offre? "Gioia vana", osserva il poeta, "ch'è frutto del passato timore": gran guadagno è per l'uomo solo una breve sosta dal dolore e veramente felice può dirsi colui che la morte libera finalmente dalla pena.
"La quiete dopo la tempesta"
Passata è la tempesta: (1)
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe là da ponente, alla montagna;
sgombrasi la campagna, (2)
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio
torna il lavoro usato.
L'artigiano a mirar l'umido cielo,
con l'opra in man, cantando,
fassi (3) in su l'uscio; a prova (4)
vien fuor la femminetta a còr dell'acqua
della novella piova;(5)
e l'erbaiuol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passegger che il suo cammin ripiglia.
Si rallegra ogni core.
Sì dolce, sì gradita
Quand'è, com'or, la vita?
Quando con tanto amore
l'uomo a' suoi studi intende?
O torna all'opre? o cosa nova imprende? (6)
Quando de' mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d'affanno;(7)
gioia vana, ch'è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudàr le genti e palpitàr, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.
O natura cortese, (8)
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge (9): e di piacer, quel tanto
che per mostro (10) e miracolo talvolta
nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni; assai felice
se respirar ti lice (11)
d'alcun dolor: beata
se te d'ogni dolor morte risana.
(1) Il poeta avverte subito la gioia che si diffonde intorno; dopo farà le sue considerazioni pensose, ma intanto coglie la gioia negli uccelli.
(2) dal denso velo di nebbia piovigginosa.
(3) si fa, si affaccia.
(4) a gara
(5) a raccogliere l'acqua della pioggia recente.
(6) incomincia quasi con gioia.
(7) è questo il tema centrale del canto: gli uccelli, le donne del paese, l'artigiano, l'erbivendolo, tutte le creature hanno aperto il loro cuore alla letizia, ma solo dopo che la tempesta li ha atterriti. Quindi il piacere nasce dal dolore e perciò non è una qualità positiva, ma una gioia vana, che è frutto "del passato timore".
(8) "cortese" ha valore ironico.
(9) il piacere è figlio dell'affanno, ma il dolore nasce spontaneamente, è uno stato naturale dell'uomo.
(10) e quel poco di piacere che talvolta, quasi per prodigio (mostro) o miracolo, nasce dal cessare del dolore, è veramente un grande acquisto.
(11) "Puoi stimarti felice se appena ti è concesso un po' di respiro da qualche dolore"
(12) "Puoi considerarti beato se la morte ti libera da tutti i mali"
Commento a "Il sabato del villaggio": ancora un quadro di vita paesana e dei più suggestivi. Nasce nell'atmosfera di festa che si diffonde nell'aria e nei cuori la sera del sabato. Il sole sta per tramontare: la contadinella torna alla campagna col suo fascio di erba sul capo e il mazzolino di fiori per potersi ornare l'indomani del giorno festivo; l'attesa gioiosa della festa si rispecchia anche nel viso della vecchiarella, che continua a filare rivolta verso il sole che tramonta rievocando i giorni della giovinezza, quando anche ella si ornava per andare a danzare con i coetanei. Intanto scende la sera: la luna diffonde la sua bianca luce e la campana annuncia la festa imminente: alle grida dei fanciulli che giocano sulla piazzola, si accompagna il fischiare dello zappatore che torna alla sua parca mensa. E quando la notte è già alta è tutt'intorno è silenzio e pace, s'ode ancora un frequente picchiare di martello: è il legnaiolo che si affretta a finire il lavoro prima che spunti l'alba: ma lavora in letizia perché poi anche lui potrà finalmente riposare. La notazioni paesistiche, nelle quali si distende questa nota di gioia, sono semplici, limpide, serene, come le anime di quel piccolo mondo che attende il giorno festivo. Ma già il poeta ha il presentimento della pena: egli sa che l'indomani le ore recheranno tristezza e noia, perché la gioia è solo nell'attesa del bene, il quale, appena raggiunto, si rivelerà vuoto. E così l'atmosfera festosa della vigilia si risolve nel rimpianto della gioia già passata prima ancora che sia goduta. Il poeta tuttavia non vuole togliere l'illusione al cuore del fanciullo che gioca e sogna e gli augura che la giovinezza tardi per lui a venire, perché quando egli sarà uomo vedrà cadere l'incanto che ha sognato.
"Il sabato del villaggio"
La donzelletta vien dalla campagna,
in sul calar del sole,
col suo fascio dell'erbe; e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,
onde, siccome suole,
ornare ella si appresta (1)
dimani, al dì di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro là dove si perde il giorno; (2)
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dì della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch'ebbe compagni dell'età più bella.
già tutta l'aria imbruna, (3)
torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre
giù da' colli e da' tetti, (4)
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dà segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e là saltando,
fanno un lieto romore:
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dì del suo riposo.
Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l'altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s'affretta, e s'adopra
di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba.(5)
Questo di sette è il più gradito giorno, (6)
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l'ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier farà ritorno.
Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita (7)
è come un giorno d'allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo'; ma la tua festa
ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
(1) con la quale si prepara
(2) col viso rivolto verso quella parte dove il sole sta per tramontare. La luce dell'ultimo sole illumina il viso della vecchiarella che partecipa alla diffusa gioia del sabato e rievoca, senza malinconia, la sua giovinezza lontana.
(3) Il sole è già tramontato
(4) sembra che le ombre scendano dai colli e dai tetti
(5) si ingegna di terminare il suo lavoro
(6) è il motivo centrale del canto: il sabato è il più caro di tutti i giorni, perché pieno di speranza e di gioia. E domani? domani, domenica, le ore porteranno tristezza e noia. La felicità è nell'attesa.
(7) la tua fanciullezza.
Commento a "Il tramonto della luna"
Primavera del 1836: il Leopardi è ospite dell'amico Antonio Ranieri in una villa di Torre del Greco, alle falde del Vesuvio. In questo luogo incantevole egli scrive il suo ultimo canto che si apre con un paesaggio - stato d'animo, il più desolato. La luna, che con la sua luce ha inargentato le campagne e le acque volge al tramonto e lontano tra le luci e le ombre create dalla semioscurità, sorgono forme indeterminate e incerte; poi quando essa cade del tutto, anche le ombre spariscono, il buio completo incombe sulla valle e sui monti e il canto mesto del carrettiere saluta la luce che fino allora lo aveva accompagnato lungo il cammino. Anche la giovinezza, che con le dolci illusioni ha allietato la vita mortale, si dilegua come la luna; e con essa si sciolgono le dilettose immagini. Ma sulle colline e nelle valli tornerà presto a splendere l'alba; per l'uomo, svanita la bella giovinezza, non ci sarà più sorriso d'altra luce o di altra aurora. E su di lui incomberà il più grave di tutti i mali: la vecchiaia. E dopo la vecchiaia, la morte.
In questo canto Leopardi esprime il suo malinconico addio alla giovinezza che si dissolve rapida ed alla vita che egli sente venir meno; si dice anzi che gli ultimi versi siano stati dettati al Ranieri due ore prima che il poeta chiudesse gli occhi e il cuore alle vie dorate, agli orti, al "primo degli augelli sussurro", alle montagne serene, alla notte dolce e chiara senza vento, ai suggestivi paesaggi lunari che anche nelle altre liriche egli aveva rimpianto, ma con un sentimento meno desolato di quello espresso in "Tramonto della luna"
"Tramonto della Luna"
Quale in notte solinga, (1)
sovra campagne inargentate ed acque,
là 've zefiro aleggia,
e mille vaghi aspetti
e ingannevoli obbietti
fingon l'ombre lontane
infra l'onde tranquille
e rami e siepi e collinette e ville;
giunta al confin del cielo,
dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno
nell'infinito seno
scende la luna; e si scolora il mondo;
spariscon l'ombre, ed una
oscurità la valle e il monte imbruna;
orba la notte resta, (2)
e cantando, con mesta melodia,
l'estremo albor della fuggente luce,
che dianzi gli fu duce,
saluta il carrettier dalla sua via; (3)
tal si dilegua, e tale
lascia l'età mortale
la giovinezza. In fuga
van l'ombre e le sembianze
dei dilettosi inganni; (4) e vengon meno
le lontane speranze,
ove s'appoggia la mortal natura.
Abbandonata, oscura
resta la vita. In lei porgendo il guardo,
cerca il confuso viatore invano
del cammin lungo che avanzar si sente
meta o ragione; e vede
che a sé l'umana sede,
esso a lei veramente è fatto estrano.
Troppo felice e lieta
nostra misera sorte
parve lassù, se il giovanile stato,
dove ogni ben di mille pene è frutto,
durasse tutto della vita il corso. (5)
Troppo mite decreto
quel che sentenzia ogni animale a morte,
s'anco mezza la via
lor non si desse in pria
della terribil morte assai più dura. (6)
D'intelletti immortali
degno trovato, estremo
di tutti i mali, ritrovàr gli eterni
la vecchiezza, ove fosse
incolume il desio, la speme estinta,
secche le fonti del piacer, le pene
maggiori sempre, e non più dato il bene. (7)
Voi, collinette e piagge,
caduto lo splendor che all'occidente
inargentava della notte il velo,
orfane ancor gran tempo
non resterete; (8) che dall'altra parte
tosto vedrete il cielo
imbiancar novamente, e sorger l'alba:
alla qual poscia seguitando il sole,
e folgorando intorno
con sue fiamme possenti,
di lucidi torrenti
inonderà con voi gli eterei campi.
Ma la vita mortal, poi che la bella
giovinezza sparì, non si colora
d'altra luce giammai, né d'altra aurora.
Vedova è insino al fine; ed alla notte
che l'altre etadi oscura,
segno poser gli Dei la sepoltura. (9)
(1) Come in una notte solitaria la luna, giunta all'orizzonte, dietro gli Appennini o le Alpi oppure nel seno infinito del Tirreno, scende sopra le campagne ed acque inargentate, dove spira un vento leggero di primavera (Zefiro) e le ombre lontane formano (fingono) mille aspetti indeterminati (vaghi) ed illusori (ingannevoli) fra le acque tranquille e fra i rami, le siepi, le collinette e le ville e il mondo si scolora.
(2) La notte, dopo il tramonto della luna, resta priva di luce.
(3) Il carrettiere saluta con la melodia mesta del suo canto l'ultimo chiarore lunare che ora va dileguandosi (fuggente).
Il paesaggio leopardiano assume il tono e i colori dello stato d'animo del poeta, il quale ormai sente prossima la tanto invocata morte. Egli, di questa notte, coglie l'atmosfera desolata così aderente alla sua esperienza di vita: l'ultima luce della luna si posa sopra i campi e sui colli; ad essa succede un buio profondo che sommerge i mille vaghi aspetti della natura. Lo stesso avviene nell'uomo: la giovinezza con gli ameni inganni sfocia e si dissolve nella vecchiaia. Quanta solitudine nel cielo dopo il tramonto della luna e quanta solitudine nell'anima dopo il tramonto della giovinezza!
(4) I sogni e i fantasmi creati dalle piacevoli illusioni giovanili.
(5) Nella vita umana l'unica età dove si gode di qualche bene è la giovinezza: ma gli Dei vollero togliere agli uomini anche la giovinezza, assegnandogli un male peggiore anche della morte: la vecchiaia.
(6) Se prima della morte (in pria) non si concedesse loro anche quell'altra metà della vita (mezza la via) cioè la vecchiezza.
(7) Intatto il desiderio, morta la speranza di appagarlo.
(8) Prive di luce: alla notte succederà l'alba. Torna l'alba, ma non le illusioni della giovinezza.
(9) Ed alle tenebre che oscurano le altre età dell'uomo, cioè la maturità e la vecchiaia, non la giovinezza - gli Dei posero come meta (segno) la sepoltura. Quanta desolazione, in questa chiusa!
Vittorio Alfieri: Vita e commento alla Tirannide e alle Tragedie
Tratto da
"Signore, Voi mi avete privato della vita perché m'avete creduto cattivo, comunque, nonostante il colore dei miei capelli, Vi assicuro, che io non lo fui. Mi piaceva molto criticare le azioni degli uomini, e ci mettevo spesso del fiele, ma non erano gli uomini quelli che io detestava, bensì i loro vizi e le loro ridicolezze (...) mentre deploravo l'acciecamento di coloro che perdono il loro tempo, sono sempre andato alla deriva in balia delle mie passioni, e ho molto male impiegato il mio." (Vittorio Alfieri)
"Il nascere della classe dei nobili mi giovò... moltissimo", scriveva Alfieri "per poter poi senza la taccia d'invidioso e di vile, dispregiare la nobiltà, per sé sola, svelarne le ridicolezze, gli abusi e i vizi"
Le colline d'Asti si stendono a secco d'estate, d'inverno, scolpite dal gelo, scompaiono sotto impenetrabili tessiture di nebbia. Niente sfumature, incertezze, ambiguità. Colori decisi e forti. Così, delle colline d'Asti, il Genio. Da genitori nobili, ricchi, ma di grassa ignoranza, secondo la più pura tradizione dell'aristocrazia piemontese prerisorgimentale, nel pomeriggio del 16 gennaio 1749 nasce in Asti Vittorio Alfieri.
Fisicamente gracile, spremuto e bianco per il mal dei pondi (dissenteria con flusso sanguigno) Vittorio vive un'adolescenza malinconica e chiusa.
I grandi saloni del palazzo Alfieri sono un labirinto ordinato ma senza anima. Anche la sorella Giulia scompare presto rinchiusa in monastero, secondo il costume dell'epoca.
Vittorio scriverà più tardi: "Di questo avvenimento domestico mi ricordo benissimo (...) Mi sono presentissimi i dolori e le lagrime ch'io versai in quella separazione..."
Piange e soffre, da solo e in silenzio. Nel silenzio si arroccano anche i primi capricci e le ribellioni precoci.
Costretto per castigo ad andare alla messa con la reticella da notte in capo, la prima volta cerca di resistere con la forza, si fa trascinare di peso; la seconda volta non oppone alcuna resistenza.
Malinconia, scontrosità, orgoglio, invidia, sono il bagaglio che a 9 anni il conte Vittorio porta con sé nei lugubri appartamenti dell'Accademia Militare di Torino. Obbligato a studiare grammatica, retorica, filosofia, matematica, fisica, diritto civile e canonico, tutto condito in un latino inutile e pedantesco, Vittorio si procura di nascosto i quattro tomi dell'Orlando Furioso, che gli vengono presto sequestrati: è assolutamente vietato abbandonare il latino per le sciocche rime italiane di un volgare autore d'avventure.
"Io viveva frattanto in tutto e per tutto ignoto a me stesso; non mi credendo vera capacità per nessuna cosa al mondo; non avendo nessunissimo impulso deciso altro che alla continua malinconia; non ritrovando mai pace né requie, e non sapendo pur mai quello che io mi desiderassi"
Ottenuto il permesso regale di viaggiare al di fuori del Piemonte, Vittorio visita Milano, Bologna, Firenze, Lucca, Pisa, Livorno, Siena, Roma, Napoli, Venezia, Parigi (che lo delude) e infine Londra. Nessun monumento, opera d'arte, paesaggio, niente smorza la sua istintiva irrequietezza. Una giovane donna, Cristina Imholf, incontrata per caso, amata per gioco, e persa per un trasferimento del marito, riesce a fermare l'Alfieri. A 19 anni tenta il suicidio e viene salvato dal domestico. Il 29 settembre 1768 Vittorio e il servitore rientrano in Piemonte. Si appassiona a Montesquieu e Plutarco, e gli viene proposto un matrimonio d'interesse, che poi viene annullato perché i modi strani di Vittorio non convincono i parenti della promessa sposa. Così Vittorio parte per Vienna, poi per la Danimarca e la Svezia. Il suo furore e l'odio per la Prussia si sfogano in lunghe corse sulla slitta "per quelle cupe selvone, e su quei lagoni incrostati". Alla fine del '70 è di nuovo a Londra. Qui conosce Penelope Pitt, moglie di Lord Ligonier e per la seconda volta si innamora. A Torino s'insedia in un grande e lussuoso appartamento affacciato sulla piazza San Carlo, e riesumati i vecchi amici fonda con loro una strana accademia letteraria. Si innamora della marchesa Gabriella Falletti Turinetti e la malattia d'amore lo riduce per quasi tre anni al grado di servilismo più basso; lunghe ore di ozio e alla fine la noia lo riportano lentamente alla realtà. Scopre, a 26 anni, la vocazione per il teatro, come luogo di ribellione e di lotta, pulpito civile per il grido della libertà contro qualsiasi forma di oppressione capace di minacciare lo sviluppo dell'individuo.
Si piega sui libri, studia: oltre alla tragedia "Cleopatra", scrive "Filippo", "Polinice", "Antigone", "Agamennone", "Oreste", "Don Garzia". S'innamora di Machiavelli e compone il trattato politico "Della Tirannide". La donna che gli ruba il cuore in questo periodo è Luisa, contessa d'Albany.
Alla fine del'80, Alfieri compone le prime quattro odi all'"America libera" e le tragedie "Merope" e "Saul". Seguono altri numerosi viaggi.
è nel '90 che comincia a rievocare il proprio passato scrivendo la prima parte della "Vita". Muore dopo averne completato la seconda parte, nel 1803, in seguito a un forte attacco febbrile.
Se l'Alfieri uomo muore, sopravvive il suo valore: Andrea Chénier, Cesare Balbo, Santorre Santarosa, Silvio Pellico, Vincenzo Gioberti, Massimo d'Azeglio, J.C.S. Sismondi, Ludovico di Brème, August Schlegel, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Giosuè Carducci, sono tutti autori ispirati da Vittorio Alfieri: la prigione, l'esilio, la morte, la volontà di opporsi ad ogni forma di violenza e di oppressione: gli spiriti più fervidi e agguerriti, in un secolo di lotta come l'Ottocento, non potevano che essere "sanamente malati di alfierismo"
Approfondimento sull'Anima Alfieriana e le Rime, a questo link: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/vittorio-alfieri-rime-commento-la-dove.html
Fra le opere cosiddette minori, occupa il primo posto il trattato "Della Tirannide", scritto "d'un sol fiato" nel '77.
Alfieri si butta alle spalle il riformismo di Voltaire, Montesquieu, Helvétius, Rousseau; perché le riforme, anche quelle illuminate, sono sempre l'occasione migliore per aumentare il potere dei tiranni, e per addormentare l'istinto di rivolta, il desiderio di libertà. E chi detiene il potere, buono o cattivo, oscurantista o illuminato che sia, ha sempre e dovunque "una facoltà illimitata di nuocere". Nel primo libro del trattato l'Alfieri compie appunto un'attenta analisi dell'inscindibile binomio "potere-tirannia": la tirannide ha il suo fondamento "nella vicendevole paura che governa il mondo" e si regge su tre indispensabili puntelli: la nobiltà, avvilita e degradata a strumento docile di governo; l'esercito, mezzo d'oppressione e di barbarie, rifugio all'ignoranza e alla viltà, e la religione, sfruttata unicamente per la sua forte capacità di educare gli animi a servire.
Nel secondo libro, Alfieri si intrattiene sul modo di comportarsi dell'uomo libero in regime tirannico e sulla possibilità di affrancarsi dalla schiavitù. La prima possibilità, la più coraggiosa, la più decisiva, è il suicidio: come occasione per affermare la libertà, negandosi a una vita, che in regime di oppressione è già morte.
La seconda possibilità è quella di sottrarsi a qualsivoglia forma di vita sociale ritirandosi in solitudine. La terza, e ultima, è quella di uccidere il tiranno, ma con una precisa avvertenza: il tirannicidio per se stesso non è in grado di eliminare la tirannide, anzi, nella forma collettiva e lungamente calcolata della congiura ha sovente un esito rafforzativo; si giustifica perciò nella forma dell'attentato individuale come manifestazione di un animo offeso e già disposto a morire: ancora una volta, in un modo di suicidio. Il "Della Tirannide" rappresenta perciò una rottura, nel quadro della cultura politica dell'epoca. Alfieri non disquisisce sul modo migliore di governare, di gestire il potere, come avevano fatto gli illuministi francesi. Condanna invece qualunque forma di potere in senso assoluto; alza un monumento all'indeterminato impulso rivoluzionario, alla contestazione globale ante litteram.
L'identica atmosfera di dispotismo assoluto è protagonista anche dell'"Antigone". Alfieri aveva sempre sostenuto che la crudeltà, la disperazione e l'oppressione non hanno patria e tempo, sono di sempre e di ogni dove.
La città di Tebe: il tiranno Creonte. Antigone sorella di Polinice giunta in Tebe per dar sepoltura al fratello; Argia moglie di Polinice, che l'accompagna; Emone figlio di Creonte, innamorato di Antigone: questi i personaggi e l'ambiente della tragedia.
La successione delle scene è semplice e lineare: Antigone e Argia giungono in Tebe per un pellegrinaggio funebre. Creonte nega il permesso alla sepoltura, ma le due donne disobbediscono. Interviene Emone presso il padre, supplicando di risparmiare Antigone. Il padre si dice disposto al perdono a condizione che la fanciulla sposi Emone. è questo il punto culminante della tragedia, risolto in modo originalissimo dall'Alfieri, concentrando in un solo endecasillabo cinque diverse battute, una vera esplosione di emotività e di stile:
"Scegliesti?", domanda Creonte;
"Ho scelto!", risponde Antigone.
"Emon?"
"Morte."
"L'avrai."
Nel frattempo Emone, dopo aver liberato Argia, le consegna le ceneri di Polinice. Antigone ormai è stata uccisa.
Conosciuta la sorte della donna che amava, Emone, generoso e sfortunato, si uccide, esprimendo il desiderio che i suoi resti vengano inumati accanto a quelli di Antigone.
Rispetto al "Filippo", questa terza tragedia contiene almeno due elementi nuovi che arricchiscono le tensioni sentimentali dei personaggi: la pietà religiosa di Antigone e di Argia, e, in Emone, la purezza di un amore che non è corrisposto. Immediatamente precedente è un altro lavoro sullo stesso tema: "Polinice".
La sete di regno di Eteocle ha spinto il fratello Polinice all'esilio. Lo scontro tra i due, che avrebbero dovuto regnare insieme per volere del padre, è inevitabile. Nella scena seconda dell'atto V, la sorella Antigone racconta: "Ebbro di sangue e di furor, se stesso nulla curando, purch'ei l'altro uccida, Eteocle sul misero fratello la spada, il braccio, sé tutto, abbandona"
Nella scena terza, la tragica famiglia di Edipo è raccolta al completo. Giocasta teneramente disperata, Antigone forte e virile nel suo dolore, e i due fratelli morenti, Eteocle ancora ricco di odio e Polinice che nel momento supremo trova la forza per dimenticare le offese, e per umiliarsi con parole di una generosità quasi cristiana: "Andrai del regio serto fra le avite scettrate ombre fastoso. Ma reverente in atto ombra minore vedrai fratello suddito", che non è semplicemente un chiedere
perdono, ma trionfare anche su se stesso: un atto di purificazione dinanzi alla morte, ultimo giudice.
D'ambiente romano è invece la quinta tragedia, "Virginia".
Virginia, di origine plebea, fidanzata al tribuno Icilio, avversario acerrimo di ogni tirannia, viene rapita per conto di Appio Claudio, decemviro patrizio che mirava alla sopressione della repubblica e all'instaurazione di un potere personale. Icilio e Virginio, il padre della protagonista, si accordano per muovere il popolo alla all'insurrezione, ma mentre Virginia resiste alle minacce di Appio, i sicari di quest'ultimo uccidono Icilio. L'insurrezione sembra fallire. La moltitudine, che forse gioca il ruolo più importante in tutta la tragedia, tace. Virginio, nell'impossibilità di salvare la figlia dal disonore, chiede di vederla e abbracciatala le trafigge il petto con un pugnale, restituendole così, pur con immenso dolore del padre, l'onore e la libertà.
Questa tragedia, ispirata dalla lettura della narrazione storica fattene da Tito Livio, è un vero atto di ammirazione per il mondo romano, per "la prima virtù", che il nostro Autore avrebbe tanto desiderato fosse rivissuta nell'Italia sua contemporanea.
(Nota Bene: ovviamente mi dissocio dall'idea che uccidere una figlia "per ridarle l'onore", sia un bell'atto di eroismo e virtù, anzi, al massimo è un "bell'atto" di misoginia patriarcale!!!, e per fortuna, almeno da noi, ormai debellata!!!)
Al 19 maggio 1776 risale l'ideazione di altre due tragedie: l'Agamennone e l'Oreste. Una dopo l'altro vengono stese in prosa, e a brevissima distanza di tempo versificate.
Agamennone, il re dei re, sta tornando vittoriosamente in patria. Ma mentre la nave del sovrano è in lotta con la furia del mare, nella reggia di Argo c'è chi attende e spera e c'è chi, pur nella paura, ordisce oscure macchinazioni. Egisto, figlio di Tieste, ha sostituito Agamennone sul trono e al fianco di Clitennestra. Le navi gettano le ancore, Agamennone scende: saluta la sua terra, le cose, le persone amate. In tanta gioia e serenità un'ombra si alza: "Consorte, figlia, voi taciturne state, a terra incerto fissando il guardo irrequieto?"
Le parole affettuose e riverenti della figlia Elettra restituiscono serenità ad Agamennone. Ma è cosa breve. Egisto riesce a convincere subdolamente Clitennestra della necessità che il suo rivale sia ucciso. Clitennestra, che ha già tradito, che ha già simulato una serenità compiacente di fronte al marito, è ormai matura e "degna" di compiere l'atroce impresa.
La paura di perdere l'amante, l'insinuazione di costui che il re ormai le anteponga la schiava Cassandra, non le lasciano altra via che il delitto: Clitennestra uccide Agamennone nel sonno.
Nell'"Oreste" si compie finalmente il ciclo dei presentimenti, dei terrori e delle vendette iniziatesi con l'Agamennone. Elettra si consuma nel pensiero della sua triste sorte e si consola nella speranza del ritorno del fratello Oreste. Clitennestra è vinta da cupi rimorsi; Egisto persiste nei suoi disegni di morte e progetta l'uccisione di Elettra. Oreste torna accompagnato da Pilade: incontrano Elettra ed entrano nella reggia. Si presentano a Clitennestra, attendono Egisto; violento scontro fra il tiranno e il figlio di Agamennone. Oreste sta per uccidere Egisto, ma colpisce la madre che si era frapposta. Pilade uccide Egisto: l'allucinazione del matricida è disegnata dall'Alfieri nella scena finale: "O padre, Torvo mi guardi? A me chiedesti sangue: e questo è sangue... e sol per te il versai..."
Mirra: tragedia dell'amore incestuoso che Mirra vive per il padre Ciniro, condotta sapientemente attraverso i meandri dell'anima della fanciulla incolpevole. Gli Dei, l'ira di Venere contro l'orgoglio della madre Cecri, hanno alimentato nella sua fragile carne l'orrendo peccato. Mirra è sola, abbandonata, nessuno può aiutarla. Vive soffrendo in silenzio. Solo in fine un breve velato accenno alla sua passione. è quanto basta, perché nella sua mente, quel grido ormai insopprimibile e rivelatore, sostituisca all'immagine dell'Amore-impossibile l'immagine della Passione-Morte. Mirra, con la spada del padre, si uccide.
Saul: il capolavoro dell'Alfieri. In questa tragedia non c'è più e soltanto il drammatico contrasto tra le forze del male da una parte e quelle del bene dall'altra. Saul non è semplicemente "il tiranno", come poteva essere Filippo, ma è "l'uomo" ricco di una psicologia complessa e multiforme, oppressore e vittima allo stesso tempo. Ad ogni istante il suo nemico assume un volto diverso: ora è Javé, implacabile vendicatore, ora è un imprecisato male che affligge il suo vecchio corpo, ora è l'ostilità dei sacerdoti; in altri momenti è David, insidioso rivale, altre volte Abner o il sospetto verso i suoi figli. I suoi veri nemici, sono, in verità, la sua coscienza e il mistero profondo che avvolge il breve cammino terrestre.
Caratteri e motivi della tragedia e della poesia alfieriana
Tratto da
Per un commento al "Filippo", vedi qui: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/vittorio-alfieri-commento-al-filippo.html
Per un commento più approfondito al "Saul": http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/08/il-saul-di-vittorio-alfieri-lemergere.html
Per i versi più belli di "Merope": http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/11/il-sangue-e-la-vendetta-i-versi-piu.html
Per "Maria Stuarda" http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/11/le-pagine-piu-belle-della-maria-stuarda.html
Altro post: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/01/la-tomba-di-vittorio-alfieri.html
Per i versi più belli di "La Congiura de' Pazzi": https://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/01/la-congiura-de-pazzi-di-alfieri-i-versi.html
Don Garzia: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/01/don-garzia-di-vittorio-alfieri-le.html
Mirra: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/02/mirra-di-vittorio-alfieri-i-versi-piu.html
Le incisioni più belle:
"Signore, Voi mi avete privato della vita perché m'avete creduto cattivo, comunque, nonostante il colore dei miei capelli, Vi assicuro, che io non lo fui. Mi piaceva molto criticare le azioni degli uomini, e ci mettevo spesso del fiele, ma non erano gli uomini quelli che io detestava, bensì i loro vizi e le loro ridicolezze (...) mentre deploravo l'acciecamento di coloro che perdono il loro tempo, sono sempre andato alla deriva in balia delle mie passioni, e ho molto male impiegato il mio." (Vittorio Alfieri)
"Il nascere della classe dei nobili mi giovò... moltissimo", scriveva Alfieri "per poter poi senza la taccia d'invidioso e di vile, dispregiare la nobiltà, per sé sola, svelarne le ridicolezze, gli abusi e i vizi"
Le colline d'Asti si stendono a secco d'estate, d'inverno, scolpite dal gelo, scompaiono sotto impenetrabili tessiture di nebbia. Niente sfumature, incertezze, ambiguità. Colori decisi e forti. Così, delle colline d'Asti, il Genio. Da genitori nobili, ricchi, ma di grassa ignoranza, secondo la più pura tradizione dell'aristocrazia piemontese prerisorgimentale, nel pomeriggio del 16 gennaio 1749 nasce in Asti Vittorio Alfieri.
Fisicamente gracile, spremuto e bianco per il mal dei pondi (dissenteria con flusso sanguigno) Vittorio vive un'adolescenza malinconica e chiusa.
I grandi saloni del palazzo Alfieri sono un labirinto ordinato ma senza anima. Anche la sorella Giulia scompare presto rinchiusa in monastero, secondo il costume dell'epoca.
Vittorio scriverà più tardi: "Di questo avvenimento domestico mi ricordo benissimo (...) Mi sono presentissimi i dolori e le lagrime ch'io versai in quella separazione..."
Piange e soffre, da solo e in silenzio. Nel silenzio si arroccano anche i primi capricci e le ribellioni precoci.
Costretto per castigo ad andare alla messa con la reticella da notte in capo, la prima volta cerca di resistere con la forza, si fa trascinare di peso; la seconda volta non oppone alcuna resistenza.
Malinconia, scontrosità, orgoglio, invidia, sono il bagaglio che a 9 anni il conte Vittorio porta con sé nei lugubri appartamenti dell'Accademia Militare di Torino. Obbligato a studiare grammatica, retorica, filosofia, matematica, fisica, diritto civile e canonico, tutto condito in un latino inutile e pedantesco, Vittorio si procura di nascosto i quattro tomi dell'Orlando Furioso, che gli vengono presto sequestrati: è assolutamente vietato abbandonare il latino per le sciocche rime italiane di un volgare autore d'avventure.
"Io viveva frattanto in tutto e per tutto ignoto a me stesso; non mi credendo vera capacità per nessuna cosa al mondo; non avendo nessunissimo impulso deciso altro che alla continua malinconia; non ritrovando mai pace né requie, e non sapendo pur mai quello che io mi desiderassi"
Si piega sui libri, studia: oltre alla tragedia "Cleopatra", scrive "Filippo", "Polinice", "Antigone", "Agamennone", "Oreste", "Don Garzia". S'innamora di Machiavelli e compone il trattato politico "Della Tirannide". La donna che gli ruba il cuore in questo periodo è Luisa, contessa d'Albany.
Alla fine del'80, Alfieri compone le prime quattro odi all'"America libera" e le tragedie "Merope" e "Saul". Seguono altri numerosi viaggi.
è nel '90 che comincia a rievocare il proprio passato scrivendo la prima parte della "Vita". Muore dopo averne completato la seconda parte, nel 1803, in seguito a un forte attacco febbrile.
Se l'Alfieri uomo muore, sopravvive il suo valore: Andrea Chénier, Cesare Balbo, Santorre Santarosa, Silvio Pellico, Vincenzo Gioberti, Massimo d'Azeglio, J.C.S. Sismondi, Ludovico di Brème, August Schlegel, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Giosuè Carducci, sono tutti autori ispirati da Vittorio Alfieri: la prigione, l'esilio, la morte, la volontà di opporsi ad ogni forma di violenza e di oppressione: gli spiriti più fervidi e agguerriti, in un secolo di lotta come l'Ottocento, non potevano che essere "sanamente malati di alfierismo"
Approfondimento sull'Anima Alfieriana e le Rime, a questo link: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/07/vittorio-alfieri-rime-commento-la-dove.html
Fra le opere cosiddette minori, occupa il primo posto il trattato "Della Tirannide", scritto "d'un sol fiato" nel '77.
Alfieri si butta alle spalle il riformismo di Voltaire, Montesquieu, Helvétius, Rousseau; perché le riforme, anche quelle illuminate, sono sempre l'occasione migliore per aumentare il potere dei tiranni, e per addormentare l'istinto di rivolta, il desiderio di libertà. E chi detiene il potere, buono o cattivo, oscurantista o illuminato che sia, ha sempre e dovunque "una facoltà illimitata di nuocere". Nel primo libro del trattato l'Alfieri compie appunto un'attenta analisi dell'inscindibile binomio "potere-tirannia": la tirannide ha il suo fondamento "nella vicendevole paura che governa il mondo" e si regge su tre indispensabili puntelli: la nobiltà, avvilita e degradata a strumento docile di governo; l'esercito, mezzo d'oppressione e di barbarie, rifugio all'ignoranza e alla viltà, e la religione, sfruttata unicamente per la sua forte capacità di educare gli animi a servire.
Nel secondo libro, Alfieri si intrattiene sul modo di comportarsi dell'uomo libero in regime tirannico e sulla possibilità di affrancarsi dalla schiavitù. La prima possibilità, la più coraggiosa, la più decisiva, è il suicidio: come occasione per affermare la libertà, negandosi a una vita, che in regime di oppressione è già morte.
La seconda possibilità è quella di sottrarsi a qualsivoglia forma di vita sociale ritirandosi in solitudine. La terza, e ultima, è quella di uccidere il tiranno, ma con una precisa avvertenza: il tirannicidio per se stesso non è in grado di eliminare la tirannide, anzi, nella forma collettiva e lungamente calcolata della congiura ha sovente un esito rafforzativo; si giustifica perciò nella forma dell'attentato individuale come manifestazione di un animo offeso e già disposto a morire: ancora una volta, in un modo di suicidio. Il "Della Tirannide" rappresenta perciò una rottura, nel quadro della cultura politica dell'epoca. Alfieri non disquisisce sul modo migliore di governare, di gestire il potere, come avevano fatto gli illuministi francesi. Condanna invece qualunque forma di potere in senso assoluto; alza un monumento all'indeterminato impulso rivoluzionario, alla contestazione globale ante litteram.
L'identica atmosfera di dispotismo assoluto è protagonista anche dell'"Antigone". Alfieri aveva sempre sostenuto che la crudeltà, la disperazione e l'oppressione non hanno patria e tempo, sono di sempre e di ogni dove.
La città di Tebe: il tiranno Creonte. Antigone sorella di Polinice giunta in Tebe per dar sepoltura al fratello; Argia moglie di Polinice, che l'accompagna; Emone figlio di Creonte, innamorato di Antigone: questi i personaggi e l'ambiente della tragedia.
La successione delle scene è semplice e lineare: Antigone e Argia giungono in Tebe per un pellegrinaggio funebre. Creonte nega il permesso alla sepoltura, ma le due donne disobbediscono. Interviene Emone presso il padre, supplicando di risparmiare Antigone. Il padre si dice disposto al perdono a condizione che la fanciulla sposi Emone. è questo il punto culminante della tragedia, risolto in modo originalissimo dall'Alfieri, concentrando in un solo endecasillabo cinque diverse battute, una vera esplosione di emotività e di stile:
"Scegliesti?", domanda Creonte;
"Ho scelto!", risponde Antigone.
"Emon?"
"Morte."
"L'avrai."
Nel frattempo Emone, dopo aver liberato Argia, le consegna le ceneri di Polinice. Antigone ormai è stata uccisa.
Conosciuta la sorte della donna che amava, Emone, generoso e sfortunato, si uccide, esprimendo il desiderio che i suoi resti vengano inumati accanto a quelli di Antigone.
Rispetto al "Filippo", questa terza tragedia contiene almeno due elementi nuovi che arricchiscono le tensioni sentimentali dei personaggi: la pietà religiosa di Antigone e di Argia, e, in Emone, la purezza di un amore che non è corrisposto. Immediatamente precedente è un altro lavoro sullo stesso tema: "Polinice".
La sete di regno di Eteocle ha spinto il fratello Polinice all'esilio. Lo scontro tra i due, che avrebbero dovuto regnare insieme per volere del padre, è inevitabile. Nella scena seconda dell'atto V, la sorella Antigone racconta: "Ebbro di sangue e di furor, se stesso nulla curando, purch'ei l'altro uccida, Eteocle sul misero fratello la spada, il braccio, sé tutto, abbandona"
Nella scena terza, la tragica famiglia di Edipo è raccolta al completo. Giocasta teneramente disperata, Antigone forte e virile nel suo dolore, e i due fratelli morenti, Eteocle ancora ricco di odio e Polinice che nel momento supremo trova la forza per dimenticare le offese, e per umiliarsi con parole di una generosità quasi cristiana: "Andrai del regio serto fra le avite scettrate ombre fastoso. Ma reverente in atto ombra minore vedrai fratello suddito", che non è semplicemente un chiedere
perdono, ma trionfare anche su se stesso: un atto di purificazione dinanzi alla morte, ultimo giudice.
D'ambiente romano è invece la quinta tragedia, "Virginia".
Virginia, di origine plebea, fidanzata al tribuno Icilio, avversario acerrimo di ogni tirannia, viene rapita per conto di Appio Claudio, decemviro patrizio che mirava alla sopressione della repubblica e all'instaurazione di un potere personale. Icilio e Virginio, il padre della protagonista, si accordano per muovere il popolo alla all'insurrezione, ma mentre Virginia resiste alle minacce di Appio, i sicari di quest'ultimo uccidono Icilio. L'insurrezione sembra fallire. La moltitudine, che forse gioca il ruolo più importante in tutta la tragedia, tace. Virginio, nell'impossibilità di salvare la figlia dal disonore, chiede di vederla e abbracciatala le trafigge il petto con un pugnale, restituendole così, pur con immenso dolore del padre, l'onore e la libertà.
Questa tragedia, ispirata dalla lettura della narrazione storica fattene da Tito Livio, è un vero atto di ammirazione per il mondo romano, per "la prima virtù", che il nostro Autore avrebbe tanto desiderato fosse rivissuta nell'Italia sua contemporanea.
(Nota Bene: ovviamente mi dissocio dall'idea che uccidere una figlia "per ridarle l'onore", sia un bell'atto di eroismo e virtù, anzi, al massimo è un "bell'atto" di misoginia patriarcale!!!, e per fortuna, almeno da noi, ormai debellata!!!)
Al 19 maggio 1776 risale l'ideazione di altre due tragedie: l'Agamennone e l'Oreste. Una dopo l'altro vengono stese in prosa, e a brevissima distanza di tempo versificate.
Agamennone, il re dei re, sta tornando vittoriosamente in patria. Ma mentre la nave del sovrano è in lotta con la furia del mare, nella reggia di Argo c'è chi attende e spera e c'è chi, pur nella paura, ordisce oscure macchinazioni. Egisto, figlio di Tieste, ha sostituito Agamennone sul trono e al fianco di Clitennestra. Le navi gettano le ancore, Agamennone scende: saluta la sua terra, le cose, le persone amate. In tanta gioia e serenità un'ombra si alza: "Consorte, figlia, voi taciturne state, a terra incerto fissando il guardo irrequieto?"
Le parole affettuose e riverenti della figlia Elettra restituiscono serenità ad Agamennone. Ma è cosa breve. Egisto riesce a convincere subdolamente Clitennestra della necessità che il suo rivale sia ucciso. Clitennestra, che ha già tradito, che ha già simulato una serenità compiacente di fronte al marito, è ormai matura e "degna" di compiere l'atroce impresa.
La paura di perdere l'amante, l'insinuazione di costui che il re ormai le anteponga la schiava Cassandra, non le lasciano altra via che il delitto: Clitennestra uccide Agamennone nel sonno.
Nell'"Oreste" si compie finalmente il ciclo dei presentimenti, dei terrori e delle vendette iniziatesi con l'Agamennone. Elettra si consuma nel pensiero della sua triste sorte e si consola nella speranza del ritorno del fratello Oreste. Clitennestra è vinta da cupi rimorsi; Egisto persiste nei suoi disegni di morte e progetta l'uccisione di Elettra. Oreste torna accompagnato da Pilade: incontrano Elettra ed entrano nella reggia. Si presentano a Clitennestra, attendono Egisto; violento scontro fra il tiranno e il figlio di Agamennone. Oreste sta per uccidere Egisto, ma colpisce la madre che si era frapposta. Pilade uccide Egisto: l'allucinazione del matricida è disegnata dall'Alfieri nella scena finale: "O padre, Torvo mi guardi? A me chiedesti sangue: e questo è sangue... e sol per te il versai..."
Mirra: tragedia dell'amore incestuoso che Mirra vive per il padre Ciniro, condotta sapientemente attraverso i meandri dell'anima della fanciulla incolpevole. Gli Dei, l'ira di Venere contro l'orgoglio della madre Cecri, hanno alimentato nella sua fragile carne l'orrendo peccato. Mirra è sola, abbandonata, nessuno può aiutarla. Vive soffrendo in silenzio. Solo in fine un breve velato accenno alla sua passione. è quanto basta, perché nella sua mente, quel grido ormai insopprimibile e rivelatore, sostituisca all'immagine dell'Amore-impossibile l'immagine della Passione-Morte. Mirra, con la spada del padre, si uccide.
Saul: il capolavoro dell'Alfieri. In questa tragedia non c'è più e soltanto il drammatico contrasto tra le forze del male da una parte e quelle del bene dall'altra. Saul non è semplicemente "il tiranno", come poteva essere Filippo, ma è "l'uomo" ricco di una psicologia complessa e multiforme, oppressore e vittima allo stesso tempo. Ad ogni istante il suo nemico assume un volto diverso: ora è Javé, implacabile vendicatore, ora è un imprecisato male che affligge il suo vecchio corpo, ora è l'ostilità dei sacerdoti; in altri momenti è David, insidioso rivale, altre volte Abner o il sospetto verso i suoi figli. I suoi veri nemici, sono, in verità, la sua coscienza e il mistero profondo che avvolge il breve cammino terrestre.
Caratteri e motivi della tragedia e della poesia alfieriana
Tratto da
La decisione alfieriana di privilegiare il teatro tragico va attribuita al fatto che la tragedia, in quanto genere letterario fondato sulla rappresentazione di intense passioni ma anche fortemente strutturato, consente allo scrittore piemontese di soddisfare due esigenze per lui ugualmente fondamentali: da un lato, quella di consentire il libero dispiegamento di una personalità irruente e appassionata, e dall'altro quella di racchiudere istinti e impulsi passionali in una cornice di compostezza e di organicità, grazie all'obbligo di attenersi alle regole classiche.
Il poeta dunque non apporta variazioni alla struttura della tragedia antica e rispetta le unità aristoteliche; ciononostante introduce all'interno dello schema classico elementi originali e di grande modernità, fra cui il procedimento in tre fasi, seguito per la stesura.
Al di là della tecnica e dei soggetti, le tragedie sono accomunate da un solo motivo: la lotta, lo scontro durissimo che oppone un individuo eroico a una realtà ostile, sia essa rappresentata da un altro uomo o da una forza interiore.
Questo schema generale si approfondisce e si arricchisce di sfumature nel corso degli anni.
Nelle prime tragedie ("Filippo", "Antigone") predomina la contrapposizione esteriore, fisica, tra un eroe e un tiranno; ma poco a poco la prospettiva muta e l'interesse dello scrittore si sposta sul conflitto interiore, sull'urto tra componenti diverse che agitano e turbano un unico personaggio. Del resto, fin dalle prime opere l'Alfieri sembra muoversi all'interno di un circolo vizioso e, come già avveniva nei trattati politici, l'alternativa tra tirranicidio e suicidio si rivela fittizia.
L'eroe e il tiranno sono figure solo apparentemente antitetiche, sono due facce di una stessa personalità. Esse incarnano l'eterno conflitto tra il bene e il male, la lacerazione psicologica, la doppiezza degli istinti che convivono in un solo uomo. L'eroe suicida non è molto diverso da chi, nel sopprimere il tiranno, uccide "l'altra parte di sé".
Lo spostamento di prospettiva è il più evidente nelle ultime tragedie. In esse, i personaggi non protagonisti assolvono una funzione ormai marginale e tendono a sfumare, quasi a scomparire ripetto all'"un solo", preda e vittima della propria inquietudine, travolto dal processo fatale e irriversibile che lo condurrà alla distruzione o, più spesso, all'autodistruzione.
Tale aspetto si nota benissimo nelle tragedie maggiori, il "Saul" e la "Mirra", che a ragione possono essere definite "Tragedie psicologiche". In ambedue il protagonista è unico, un personaggio "appassionato di due passioni tra loro contrarie", che "a vicenda vuole e disvuole una cosa stessa".
Questo conflitto di sentimenti determina la crisi di re Saul, lacerato tra la superbia e il senso di colpa verso il genero David, tra la brama di dominio, non ancora spenta, e il profondo aspetto paterno.
Saul è consapevole della propria iniquità nel perseguitare David, ma è incapace di porvi rimedio, perché in David, che Dio ha destinato a succedergli sul trono, egli già vecchio, vede il trionfo della giovinezza e della forza che la natura stessa gli impedisce ormai di avere. Il suicidio è la sola risorsa che gli resta per cercar di superare le sue contraddizioni e riscattare la propria anima in un estremo recupero di grandezza morale.
Ancora più insanabile è il contrasto che agita Mirra: per lei il suicidio è l'unica forma di riscatto per quell'amore incestuoso che la legge degli uomini condanna e che ella per prima vive come una colpa, cercando vanamente di nasconderlo e di reprimerlo.
In ambedue le tragedie l'Alfieri sottolinea vigorosamente lo scontro tra l'aspirazione dell'individuo ad affermare se stesso attraverso un eroismo sovrumano e la consapevolezza dei limiti imposti dalla fragilità umana.
Dalla contraddizione emerge un senso profondo di pessimismo, una tendenza a ripiegarsi, a indagare dentro di sé e, infine, quasi una forma di incapacità di vivere, che spinge a cercare la liberazione nella morte.
A differenza degli Illuministi, i quali tendono alla conquista del benessere per la società intera e quindi di un utile collettivo e concreto, l'Alfieri interpreta la vita e l'arte come una lotta del singolo contro tutto ciò che si oppone alla sua ricerca di libertà interiore; alla radice di ogni sua scelta esistenziale e poetica si trova quindi il convincimento che l'individuo debba tendere all'affermazione di se stesso, avere "una sete insaziabile di ben fare e di gloria...un'infiammata e risoluta voglia o di esser primo fra gli ottimi, o di non esser nulla", nella prospettiva di una vittoria personale e ideale.
Per l'Alfieri qualunque azione umana, anche la lotta contro la tirannide, è sempre la sfida astratta e aristocratica di un eroe solo e indomabile, teso verso la conquista di una libertà assoluta e priva di compromessi, a cui si oppone un potente altrettanto solo e dotato di altrettanta, sia pur perversa, grandezza.
Alla base del pensiero dell'Alfieri sta dunque un'evidente perdita di identità storica; il suo "eroe" vive fuori e spesso in contrasto con il mondo della storia, e la lotta contro il potere si traduce in una condizione esistenziale, avulsa dallo spazio e dal tempo, che difficilmente riesce a trasformarsi in azione.
I mezzi concreti che l'Alfieri indica per sottrarsi alla schiavitù e per garantire all'uomo la sua individualità e atipicità si riducono in sostanza a tre.
Il primo è l'isolamento, premessa indispensabile per ricercare la gloria, "del pensar, del dire e dello scrivere", e per evitare il conformismo, che si annida e si espande in ogni classe e in ogni concezione sociale e politica, anche in quelle apparentemente progressiste.
Il secondo è il suicidio, ossia il "generosamente morire per non vivere servo", non una sorta di sconfitta, ma affermazione o riscatto eroico della propria libertà di uomo (Nota di Lunaria: questo passaggio ha una valenza "satanica", nel senso originario del termine: non si accetta di aspettare che sia il dio cristiano a scegliere quando farci morire, ma si decide da sé quando è venuto il momento giusto per farlo all'apice del proprio successo, perché si è il Dio/la Dea di se stessi).
Infine, vi è il tirannicidio, che è un gesto di rivolta estrema.
Esso tuttavia deve rimanere un atto del singolo, un'impresa individuale; infatti la congiura, progettata ed eseguita da più persone, contiene sempre elementi di ambiguità e permette di uccidere il tiranno ma non di cancellare la tirannide.
Nella prospettiva alfieriana, il tirannicidio si avvicina e quasi coincide con il suicidio, perché chi si erge contro l'oppressore è già disposto a sacrificare la propria vita.
Questa concezione, più volte espressa nelle tragedie e nei trattati politici, risale alla cultura antica e in particolare alla trasfigurazione ideale dell'eroe che l'Alfieri trova in Plutarco, lo scrittore da lui forse più amato. Nelle "Vite Parallele" dello storico greco egli vede rivivere figura magnanime, capaci di "dire o fare alte cose".
All'inizio della "Vita", l'Alfieri dichiara che a scrivere di sé lo ha spinto "l'amor di se stesso". In altre parole, il poeta è l'eroe per eccellenza: l'uomo reso eccezionale dalla intensità dei sentimenti e dalla nobiltà dei suoi ideali: è consapevole del suo talento e lo mette al servizio della verità e della bellezza; alla capacità di agire egli stesso in prima persona, unisce anche e soprattutto quella di ispirare e guidare l'azione altrui attraverso il linguaggio eterno e sublime della poesia; è il vate, il profeta che ha il compito di diffondere e di esaltare i principi di libertà e di trasmettere i più nobili valori morali.
ALTRO APPROFONDIMENTO, tratto da
Spesso, di un grande personaggio si dice che "la sua vita fu un romanzo" o "il suo capolavoro fu la sua vita": per Vittorio Alfieri (che se resuscitasse, oggigiorno sarebbe innamorato di Lunaria, ovviamente) il suo capolavoro fu la sua "Vita", l'autobiografia più famosa della letteratura italiana.
E la sua vita fu piena di furenti passioni, di tentati suicidi e di ideali contro ogni meschinità, di riscatto morale che riabilitò una giovinezza sprecata, con un'incredibile e ferrea applicazione agli studi nell'età matura; l'impegno dell'Alfieri diede un senso al vacuo anelare verso un ideale ancora imprecisato, facendosi portavoce di un impegno morale e civile, la conquista della Libertà.
Vittorio Alfieri nacque ad Asti nel 1749, figlio di un conte e di una contessa.
Eppure, forse proprio per questo, Vittorio fu ribelle alle convinzioni nobiliari: "Il nascere della classe dei nobili, mi giovò... moltissimo", scriveva Alfieri, "per poter poi, senza la taccia d'invidioso e di vile, dispregiare la nobiltà per sé sola, svelarne le ridicolezze, gli abusi, ed i vizi".
Frequentò fino ai 17 anni l'Accademia di Torino, appassionandosi ai cavalli; poi vagò per l'Europa dopo aver visitato l'Italia e averla trovata "piena di ipocriti fantocci" (Nota di Lunaria: vedesse oggigiorno, come siamo messi...)
E all'estero trovò lo stesso campionario di cavalieri con il codino incipriato, di damine ignoranti (per l'appunto, Egli già vagheggiava Lunaria, meditando di darsi a lei anima e cuore...), di artisti ritenuti grandi che si avvilivano a fare "la genuflessioncella d'uso" ai potenti e insulsi sovrani.
Così, mentre portava in giro la sua rabbiosa furia, sperando di trovare qualche ideale per cui vivere e morire, passando da un amore ad un duello, da una crisi di disperazione all'esaltazione per la propria originalità d'ingegno, nacque in lui il desiderio "di farsi di ferro in un secolo in cui gli altri erano di polenta":
"Io viveva frattanto in tutto e per tutto ignoto a me stesso (...) non avendo nessunissimo impulso deciso altro che alla continua malinconia; non ritrovando mai pace né requie"
Ed egli intuì la sua strada mentre stava vegliando un ammalato:
gli venne il desiderio di scrivere una tragedia su Cleopatra, la cui immagine poteva ammirare da un arazzo appeso al muro.
Quando l'opera fu completa, la fece rappresentare.
Fu un enorme successo, tra repliche applauditissime al Teatro di Torino.
Il pubblico andò in estasi di fronte a questa tragedia, scritta da un giovane italiano.
L'Alfieri capì che se voleva seguire la strada dell'arte e del teatro doveva formarsi una solida cultura: "Volli, sempre volli, fortissimamente volli": aveva 27 anni, doveva rimediare a dieci anni spesi male, e armato di volontà, si fece persino legare alla sedia per darsi ad uno studio furibondo.
Morì nel 1803, celebrato come il padre della Tragedia Italiana.
Non possiamo capire fino in fondo la portata delle sue innovazioni teatrali se non ricordiamo quel che era diventato il teatro ai suoi tempi: uno spettacolo pieno di paccottiglia sentimentale-decorativa, senza nerbo, raramente con qualcosa di serio da dire.
L'essenzialità, la stringatezza dei versi alfieriani, è il mezzo per far risaltare in tutta la sua vigorosa nudità il contenuto delle sue tragedie.
Il tema fondamentale dell'Alfieri è sempre quello della Libertà, in special modo politica e civile.
Vittorio Alfieri sottolinea sempre l'esaltazione del Ribelle, dell'Eroe che va contro l'ordine precostituito (1), contro la tirannia.
I suoi drammi vogliono insegnare il gusto della libertà eroica e l'Arte è lo strumento che ridesta la coscienza addormentata.
Altri temi affrontati dall'Alfieri sono l'amore e l'ambizione.
Come sosteneva l'Alfieri:
"Io credo fermamente che gli uomini debbano imparare in teatro ad essere liberi, forti, generosi, trasportati per la vera virtù, insofferenti d'ogni violenza, amanti della patria, veri conoscitori dei propri diritti, e in tutte le passioni loro ardenti, retti e magnanimi.
Tale era il teatro d'Atene, e tale non può essere mai un teatro cresciuto all'ombra d'un principe qualsivoglia..."
Da questi nobili intenti educativi traggono vigore i personaggi alfieriani: Bruto, Oreste, Antigone, Don Garzia, Saul... titani che declamano con enfasi eroica.
Alfieri ha la stessa concezione della tragedia classica greca:
nel teatro alfieriano non ci sono personaggi scialbi, trascurabili, sono abolite le scene non essenziali, i personaggi secondari, le comparse.
Tutti, sia i tiranni sia gli eroi che li fronteggiano, sono protagonisti:
"La mia maniera (...) è sempre di camminare quanto so a grandi passi verso il fine (...) Chi ha osservato l'ossatura di una delle mie tragedie, le ha quasi tutte osservate. Il primo atto brevissimo (...) molto dialogo; i quinti atti strabrevi, rapidissimi favellatori. Ecco in uno scorcio l'andamento similissimo di tutte le mie tragedie."
Drammatica sinteticità, violenti e frequenti scontri verbali tra eroe ribelle e tiranno, scarsi i fatti che accadono, perché tutto il dramma si accentra nel dialogo.
Anzi, l'Autore sopprime l'azione che dovrebbe concludere il dramma, il tirannicidio, la vittoria della Libertà sull'oppressione: preferisce lasciare nella mente dello spettatore l'attesa della vendetta sacra, preferendo anche mostrare la tirannia che uccide se stessa, il tiranno che espia l'inevitabile punizione.
Di Saul, personaggio della sua tragedia più celebre, che incarna il tiranno, Alfieri fa dire al profeta:
"E tu chi sei? Re della terra sei:
ma innanzi a Dio, chi re? - Saùl, rientra in te; non sei che coronata polve"
E la punizione del tiranno giungerà il giorno della battaglia contro i Filistei.
Saul, ormai distrutto e vinto, si ucciderà gettandosi sulla sua spada:
"[...] Sei paga, d'inesorabil Dio terribil ira?
Ma tu mi resti, o brando: all'ultim uopo.
Fido ministro, or vieni. Ecco già gli urli dell'insolente vincitor: sul ciglio
già lor fiaccole ardenti balenarmi
veggo, e le spade a mille... Empia Filiste me troverai, ma almen da re, qui...
(nell'atto ch'ei cade trafitto sulla propria spada soprarrivano in folla i Filistei vittoriosi con fiaccole incendiarie e brandi insanguinati. Mentre costoro corrono con alte grida verso Saul, cade il sipario)
...morto"
è una scena di terribile grandezza, sostenuta dalla maestria tecnica del far irrompere i nemici vittoriosi proprio nell'atto estremo del suicidio, come indica la didascalia dello stesso Autore.
Saul, il tiranno, è morto: il limite della demarcazione fra Bene e Male è nettissimo nei personaggi alfieriani.
La concisione dell'Alfieri, necessaria all'essenzialità dei suoi drammi, era frutto di un paziente lavoro di revisione: Alfieri sfrondava versi su versi, fino ad arrivare ad una stringatezza incredibile.
La prima scena del quarto atto dell'"Antigone" è stata resa così:
- Scegliesti?
- Ho scelto.
- Emon?
- Morte.
- L'avrai.
L'ultima scena del secondo atto del "Filippo" è stata ridotta a pochissimi versi:
- Udisti?
- Udii.
- Vedesti?
- Io vidi.
- Oh, rabbia!
Dunque il sospetto?
- è ormai certezza.
- E inulto [invendicato]
Filippo è ancor?
- Pensa.
- Pensai. Mi segui.
A volte questi dialoghi alfieriani sono ermetici, quasi come se fossero un parlare cifrato.
L'atmosfera asciutta, però, è drammatica e solenne.
Tuttavia, all'epoca, il linguaggio alfieriano venne parodiato in molti modi: venne composta una pseudo tragedia alfieriana che venne rappresentata spacciandola per autentica; i personaggi erano solo tre, Socrate, sua moglie Santippe e Platone. Il tenore era di questo tipo:
- Dillo.
- Nullo.
- Non sailo?
- Sollo.
- Sallo.
Il pubblico scambiò la parodia per una vera tragedia alfieriana e applaudì quello che credeva essere il nuovo capolavoro di Vittorio Alfieri...
Vittorio Alfieri visse in quell'tà di trapasso tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ondeggiando tra Classicismo e Pre-Romanticismo: la forma è classica ma il contenuto è preromantico... non a caso tutto l'Ottocento romantico si riconosceva nello spirito di quel ribelle precursore dei tempi nuovi.
Nota di Lunaria: a me piacciono anche le poesie di Vittorio Alfieri.
Certamente, a vedere tutto quanto io ho trascritto per celebrarlo, egli Mi amerebbe di una devozione appassionata, scrivendo per Me una nuova tragedia...
LE TRAGEDIE ALFIERIANE:
Filippo
Polinìce
Antìgone
Virginia
Agamènnone
Oreste
Rosmunda
Ottavia
Timoleòne
Mérope
Maria Stuarda
La congiura de' Pazzi
Don Garzìa
Saul
Agide
Sofonìsba
Bruto I
Mirra
Bruto II
Antonio e Cleopatra
Alcèste II
(1) Nota di Lunaria: Come Lucifero, ribelle contro l'autorità dittatoriale del dio padre cristiano... o il Satana ottocentesco, visto come Portatore della Fiaccola della Ragione e del Progresso contro l'oscurantismo religioso...
In un'ottica ginocentrica, la Donna che si ribella alle religioni patriarcali e misogine, affermando Se Stessa e rifiutando di prostrarsi al dio patriarcale despota e misogino: NON SERVIAM.
Comunque, l'esaltazione del Singolo, dell'Unico, che si distingue dalla massa di dementi smidollati e pecoroni, la troviamo anche in Max Stirner con "L'Unico e la sua proprietà"
Nota di Lunaria: in genere mi piace leggere Alfieri e autori simili con sottofondo dei primi Cradle of Filth, specialmente quelli di "Dusk and Her Embrace" che si abbinano così bene a queste atmosfere nonché alle mie fantasie sentimental-sessuali...
Comunque, mentre trascrivevo questo post ho messo come sottofondo i Bal Sagoth (dell'album "A Black Moon Broods Over Lemuria") perché il loro Symphonic Black Metal è teatraleggiante, con gli spoken word molto particolari (anche troppo teatraleggianti, in un cd come "Battle Magic", che eccedeva in effetti "epici e sinfonici"...) e quindi si abbina bene parlando di teatro...
Devo dire che all'epoca (1999) i Bal Sagoth non li considerai molto, anche perché nelle recensioni e nei commenti sulle riviste Metal venivano per lo più ridicolizzati... Li ho recuperati da un paio di anni, quando mi è venuta la nostalgia per tutto quello che è uscito tra il 1996 e il 2000... Rivalutandoli a così tanti anni di distanza devo dire che secondo me all'epoca furono poco capiti, perché piuttosto stravaganti e "avanti con i tempi"... purtroppo non li ho in formato originale! Ma volevo comprarmeli.
Anche gli Amor E Morte, band bulgara purtroppo sciolta, con
"About These Thornless Wilds" (2007) esaltano al meglio lo stile colto e tragico di Alfieri!
GALLERIA DI IMMAGINI
Per un commento più approfondito al "Saul": http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/08/il-saul-di-vittorio-alfieri-lemergere.html
Per i versi più belli di "Merope": http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/11/il-sangue-e-la-vendetta-i-versi-piu.html
Per "Maria Stuarda" http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/11/le-pagine-piu-belle-della-maria-stuarda.html
Altro post: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2017/01/la-tomba-di-vittorio-alfieri.html
Per i versi più belli di "La Congiura de' Pazzi": https://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/01/la-congiura-de-pazzi-di-alfieri-i-versi.html
Don Garzia: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/01/don-garzia-di-vittorio-alfieri-le.html
Mirra: http://deisepolcriecimiteri.blogspot.it/2018/02/mirra-di-vittorio-alfieri-i-versi-piu.html
Le incisioni più belle:
Iscriviti a:
Post (Atom)